Chapter 1: Il marinaio e il mostro
Chapter Text
GODZILLA E IL DRAGONE DORATO
Al largo delle Hawaii, il sole del primo pomeriggio scaldava l’immensa distesa del Pacifico, sovrastata da un cielo senza nuvole. L’oceano era calmo e le onde facevano muovere dolcemente una piccola imbarcazione a vela ferma in mezzo a quella vastità blu. Era una rudimentale barca a remi con un piccolo albero al centro e una botola per depositare casse e scorte. A bordo c’era un uomo sulla trentina dalla pelle olivastra, gli occhi azzurri e meditabondi e capelli e barba neri e incolti. Era alto e tozzo, al punto di essere un poco ingrombrante sulla sua barca. Aveva le braccia grosse dai muscoli definiti e le spalle larghe, ma al contempo dalla sua pancia sporgeva un rotolo di grasso poco accennato, ma ben visibile: aveva smesso di tenersi allenato molti anni prima. La sua acconciatura era ancora più trasandata: i suoi capelli erano crespi e gli scendevano oltre le spalle, li teneva legati in una semplice coda; alla barba, invece, dava giusto una spuntata una volta ogni due o tre mesi, giusto per non farla crescere troppo, ma restava sempre selvaggia. Appesa al collo, portava una grossa conchiglia.
Il marinaio, in quel momento, stava tirando su l’ultima delle reti che aveva gettato la notte prima. Per ripararsi dal sole, si era avvolto la sua veste di lino attorno alla testa a mo’ di turbante e cercava di ignorare i raggi roventi sul suo petto peloso e sulla sua schiena sfregiata e solcata per intero da una cicatrice ramificata, di quelle lasciate dai fulmini. A giudicare dal peso della rete, quel giorno aveva preso poco o niente. Quando vide il pescato, sbuffò per la delusione: solo due piccoli tonni. Non avrebbe avuto senso venderli, tanto valeva mangiarne uno quella sera e conservare l’altro. L’uomo tolse i pesci dalla rete, li decapitò e li mise in una cassetta che depositò nella botola. Negli ultimi giorni, aveva avuto proprio sfortuna: nelle altre reti non aveva trovato nulla. Non era il suo primo periodo di magra, da quando abitava alle Hawaii, ma quello era senz’altro il peggiore. Non se lo spiegava: in teoria, quello era uno dei periodi più pescosi dell’anno. Spiegò la vela, si mise seduto e afferrò i remi. Tuttavia, appena sollevò lo sguardo per tornare a navigare, vide qualcosa: una piccola sagoma all’orizzonte. Era un puntino nero che si avvicinava sempre di più: una nave. Sospettando di chi potesse trattarsi, il marinaio prese subito il suo cannocchiale dalla botola, andò a prua e osservò l’imbarcazione in arrivo. Era uno sloop piuttosto malandato, col legno consumato e coperto di cirripedi. Quando guardò l’albero, l’uomo vide la conferma di ciò che pensava: una bandiera nera con un teschio e due spade incrociate. Pirati.
“Grandioso, quelli non mancano proprio mai”
Provare a scappare era inutile: lo sloop aveva il vento a suo favore, l’avrebbe raggiunto in pochi minuti. Perciò si rassegnò ad aspettarli e a occuparsene, in un modo o nell’altro. Così ammainò la vela e si sedé a poppa a braccia incrociate, in attesa dei suoi visitatori. Nel giro di pochi minuti, lo sloop si accostò alla barchetta e gettò l’ancora. L’uomo si alzò e guardò il parapetto del vascello, a cui si affacciarono quattro uomini sudici, sfregiati, vestiti di stracci e con facce da galera. L’uomo li fissò tutti senza battere ciglio, riconoscendo subito il capitano dal cappello. Il pirata, sfoggiando un sorriso ad appena sei denti, mise le mani sui fianchi e ridacchiò:
«Pesca grossa oggi, brav’uomo?»
Il marinaio non rispose, limitandosi a corrugare la fronte. Il pirata alla sinistra del capitano, un Indiano con la testa ustionata e le orecchie tagliate, diede un’occhiata delusa alla barca a vela e si lamentò:
«Capitano, perché ci avete fatto cambiare la rotta? Per questo tizio? Avrà solo una manciata di pesci, su quel guscio di legno!»
Il capitano lo fulminò con lo sguardo e tuonò:
«Razza di idiota! Guardalo: questo è un Inglese, è chiaro come il sole! E si sa, signori, gli Inglesi sono ricchi»
Il bucaniere alla sua destra, un tipo basso e muscoloso coi capelli rossi, reclinò il capo perplesso:
«Capitano, cosa vedete di inglese in questa gallinella di mare? A me sembra uno di queste isole, con quella pelle»
Il capitano alzò gli occhi al cielo, frustrato:
«Come se non fossi un uomo di mondo! Siete stati a Londra, di questi tempi? Vi sembrano tutti bianchi? No! Ce n’è di tutti i colori, ce ne sono pure di verdi, con tutto il whiskey che ingollano! Ma lo sguardo inglese non si può confondere: guardatelo bene! Vedete quella superbia velata? Quell’arroganza? Gli Inglesi si credono i padroni del mondo e i loro occhi lo dimostrano!»
Il quarto pirata sembrò ancora più confuso:
«Siete sicuro? A me sembra che ci stia guardando come se fossimo dei buffoni»
Il capitano guardò meglio e rimase interdetto, notando che il marinaio aveva cominciato a fissarli con una faccia a metà fra l’imbarazzato e il divertito. Strinse i pugni e ringhiò:
«Be’, c’è solo un modo per scoprirlo! Da dove vieni, brav’uomo? Se menti, metterò la tua testa nel cannone e la sparerò in cielo!»
L’uomo rispose con tono infastidito:
«Mio padre è inglese»
Il capitano batté le mani soddisfatto:
«A-ha! Che vi dicevo, signori? E tua madre, brav’uomo? No, non dirmelo, non mi interessa. Hai qualcosa di scintillante per noi?»
«No» rispose il marinaio, secco.
Il capitano sogghignò:
«Bene! Sarai tu il nostro bottino! Prendetelo!»
Gli altri tre pirati lanciarono un entusiasta grido di battaglia e sfoderarono i coltelli, pronti a saltare sulla barca e rapirlo, ma quello che accadde li lasciò senza parole: il marinaio si tuffò e raggiunse la scala a pioli dello sloop, salendo a bordo di sua spontanea volontà. I quattro bucanieri sembravano confusi e interdetti. L’uomo rivolse loro un sorriso beffardo e tese i polsi congiunti, come a chiedere di farseli legare. La ciurma si scambiò degli sguardi disorientati, finché l’Indiano non domandò:
«Sei pazzo? Abbiamo intenzione di venderti come schiavo a qualche re del mercato nero cinese o turco, sai?»
Il pescatore fece spallucce e rispose, calmo e composto:
«Lo so»
«Be’, che aspettate? Prendete le catene!» ordinò il capitano, ancora confuso.
Il rosso rivolse uno sguardo circospetto all’ostaggio, mentre l’Indiano correva nella stiva, e gli chiese:
«Ci nascondi qualcosa, Inglese color fango. Chi sei? Ti prendi gioco di noi?»
L’uomo non rispose. Abbassò le mani e si tolse il sorriso dalla faccia, iniziando a guardare il pirata basso con irritazione. Passò qualche secondo di silenzio, poi l’Indiano tornò sul ponte con la corda. Il capitano gli ordinò di legare il marinaio, ma il rosso lo fermò e, andando su tutte le furie, riprese il coltello che aveva rinfoderato e si parò davanti all’uomo, paonazzo:
«Non mi piace quando mi ignorano! Tua madre non ti ha mai detto che è maleducato non rispondere, eh? Ora dimmi chi sei, o regalerò le tue trippe agli squali! Come ti chiami, eh?»
Il barcaiolo indugiò, prima di rispondere alla domanda.
«Mi chiamo Alford» rispose.
Il capitano inclinò la testa, intrigato:
«Alford, eh? È un nome insolito, dov’è che l’ho già sentito?» si chiese, lisciandosi i baffi luridi.
Il quarto pirata protestò:
«Io non l’ho mai sentito. Sicuro che non sia Ford o altro?»
«No, Alford» lo corresse il prigioniero.
Il capitano continuò a rimuginare:
«Eppure giurerei che c’era un periodo in cui tutti non facevano altro che dire Alford»
Il pescatore chiuse gli occhi, scosse la testa e sospirò, stizzito. D'un tratto, prese la conchiglia sulla sua collana, se la portò alle labbra e ci soffiò dentro; la melodia fece eco per l’oceano, disperdendosi nel vento.
«Perché l’hai fatto?» chiese l’Indiano, perplesso.
«Ho visto che a quelli delle Hawaii piace suonare le conchiglie appena possono. Volevi suonare per l’ultima volta, brav’uomo? Fai bene, perché potresti anche dire addio alle tue mani lungo la rotta. Sai com’è, il viaggio è lungo e la ciurma si annoia, ma dobbiamo tenerci allenati» sghignazzò il capitano, sarcastico.
«Volete vivere?» chiese Alford, serio.
«Eh? Cosa?» domandò il rosso.
«Via dal centro della nave» suggerì il prigioniero, prima di indietreggiare con calma verso poppa.
L’Indiano sembrò spazientirsi:
«Questo babbeo è pazzo. Lasciamo perdere, uccidiamolo e basta»
Fece per sfoderare il suo coltello quando, a un certo punto, i pirati si accorsero di un rumore in lontananza: rumore di acqua agitata che diventava più forte ogni secondo che passava. Alford non si voltò, non ne aveva bisogno: sapeva già cos’era e cosa stava per succedere. Non gli rimaneva che godersi lo spettacolo. I pirati corsero verso il parapetto sul fianco sinistro della nave e guardarono il mare. Allora anche Alford non seppe più resistere e si voltò per tenere d’occhio la scena: dall’oceano erano emerse tre file di placche scure e dai bordi frastagliati, che fendevano il mare come scogli durante una burrasca. Man mano che si avvicinavano, quelle creste emergevano sempre di più dall’acqua, finché non si rivelarono essere poco più alte dello sloop. I pirati impallidirono e iniziarono a urlare in preda al panico.
«Abbandonare la nave!» esclamò il capitano, terrorizzato.
A quel punto, si divisero e presero a correre come forsennati verso le estremità opposte del vascello. Alford ne approfittò per andare a poppa e tuffarsi nell’oceano con loro: tra poco non ci sarebbe più stata una nave su cui stare. Quando saltò in acqua, nuotò in apnea per un breve tratto prima di emergere, strofinarsi via l’acqua dal volto e girarsi per guardare cosa stesse succedendo. In quel momento, le creste travolsero lo sloop. Squarciarono in due lo scafo, ci passarono attraverso e scaraventarono via le due metà della nave. I quattro pirati non si tuffarono in tempo: lo schianto li fece letteralmente volare, prima che cadessero in acqua a peso morto. Mentre le due parti distrutte dello sloop imbarcavano acqua e iniziavano ad affondare, quelle maestose file di placche si immersero con calma, svanendo com'erano apparse. Alford non poté fare a meno di ridere sommessamente: era stato troppo divertente. Il suo unico, lieve rammarico fu il fatto che i primi a non riconoscerlo dopo anni fossero stati dei pirati.
Si guardò intorno, in cerca della sua barca a vela, e la ritrovò non molto lontano da lì. La raggiunse con delle agili bracciate, merito di tutti gli anni che aveva passato in mare fin da ragazzo, e tornò a bordo. Si tolse il turbante inzuppato dalla testa e, stando in piedi sulla prua, osservò con aria di sfida i bucanieri che si sbracciavano per aggrapparsi a delle assi di legno che si erano staccate dalla loro nave. Una volta che tutti e quattro ebbero trovato un oggetto che galleggiava, il capitano individuò Alford con lo sguardo e digrignò i denti, alzando un pugno:
«Maledetto! Non la passerai liscia, miserabile! Possa questo malefico mostro divorare anche te e farti in mille pezzi!»
«Fossi in te starei attento a non dargli idee» lo provocò Alford, sornione.
I pirati sembrarono di nuovo confusi. Almeno finché l’Indiano, dopo aver meditato per qualche secondo, trasalì ed esclamò:
«Ah! Capitano! Cosa abbiamo fatto! Lo stavamo prendendo in ostaggio!»
«Sì, e allora?» chiese il rosso, irritato.
«La conchiglia! Ha chiamato lui la bestia! È sua! E quel nome… »
Dopo un attimo di silenzio, gli altri lupi di mare sbarrarono gli occhi e il loro terrore raddoppiò:
«L’Ammazzatitani!» esclamarono, sbigottiti.
Ed eccola lì: la paura. La stessa reazione che chiunque, ai quattro angoli del mondo, aveva quando incontrava Alford e scopriva chi era. Gli occhi impauriti, la soggezione e il timore troppo grandi per rivolgergli la parola o guardarlo in faccia che ormai lo accompagnavano da anni. Non aveva importanza se la gente conoscesse il suo aspetto e il suo nome oppure no: appena la sua identità veniva svelata, qualunque cosa Alford avesse detto o fatto prima di quel momento smetteva di contare: a prescindere da tutto, lui era un mostro per chiunque.
“Come al solito: non si scappa” si disse Alford, demoralizzato.
A un certo punto, però, il capitano strinse gli occhi:
«Bada bene, Ammazzatitani: non mi importa quello che si dice di te, chi distrugge il mio sloop è un uomo morto! Morto! Mi hai sentito? Ti seguirò fino in capo al mondo per…»
All’improvviso, però, il mare alle spalle dei pirati prese a ribollire e, quando lo vide dalla sua barca, Alford riuscì a scacciare la malinconia: era arrivata la sua parte preferita. Allarmati dal ribollio, i pirati si voltarono a guardare e si ritrovarono faccia a faccia con l'imponente muso di una bestia colossale, immersa fino alle narici come un coccodrillo. I pirati urlarono terrorizzati e il mostro gigante dilatò le narici, travolgendoli con uno sbuffo di vento bagnato che fece volare via il cappello del capitano. La creatura fissò i bucanieri stringendo i minacciosi occhietti arancioni e scoprì i denti acuminati. Emerse a poco a poco fino alle spalle e oscurò i bucanieri con la sua ombra. Adesso, un gigantesco rettile marino con tre eleganti creste ossee sul dorso si stagliava sui pirati immerso fino alle spalle, fissandoli da sette metri di altezza.
Alford sorrise, incrociò le braccia e osservò i quattro lupi di mare urlare in preda al panico, incapaci di distogliere lo sguardo dalla creatura per il terrore. Il rettile gigante socchiuse la bocca con un grave muggito gorgogliante e sbuffò del fumo azzurro, come se fosse provocato dalle loro grida. A quel punto, il panico prese il sopravvento e i pirati persero il lume della ragione: abbandonarono le assi di legno e presero a sbracciarsi, nuotando in tutte le direzioni per fuggire, come se potessero andare da qualche parte. Dopo averli osservati incuriosito per un po', il mostro rivolse uno sguardo interrogativo ad Alford, in attesa di scoprire cosa voleva che facesse. Lui sollevò entrambe le braccia: se le avesse allargate tenendole in alto, significava che la creatura doveva risparmiare i pirati; se l’avesse fatto abbassandole, i bucanieri sarebbero stati spazzati via. Era un piccolo codice che i due avevano imparato a usare con gli anni, per comunicare a distanza. Alford divaricò le braccia tenendole sopra la sua testa:
«Hanno recepito il messaggio, Godzilla» disse.
Il suo titano gli rispose con un grave verso gutturale che gli fece vibrare i timpani e il diaframma, poi aggirò il pezzo di legno a cui i pirati erano aggrappati con la poca delicatezza che riuscì ad avere e si accostò alla barca di Alford, avvicinando il muso alla scialuppa. L’Ammazzatitani, allora, prese una cima fissata alla prua che terminava con un enorme lasso, prese la mira e lo lanciò, centrando il collo di Godzilla. A quel punto strinse il lasso, lo assicurò e si aggrappò all’albero, prima di fischiare. Il gojirasauro, allora, iniziò a nuotare mantenendo il muso e la cresta in superficie, trainando dolcemente la barca. Mentre navigavano verso l’isola di Oahu, Alford si ricordò di fare un meritato complimento al suo fedele compagno di avventure:
«Sei stato bravo, amico, stai imparando: per pirati e banditi, resta sul semplice. Il raggio lascialo pure ai titani, quando serve. Speravo che l’avessi capita!»
Godzilla sollevò leggermente il muso dall’acqua ed emise un basso gorgoglio di contentezza, riconoscendo la lode dal tono dell’umano. Con un sorriso compiaciuto, Alford si sedé a poppa e si godé la piacevole brezza sul viso e sul petto ad occhi chiusi, in attesa di arrivare alla terraferma.
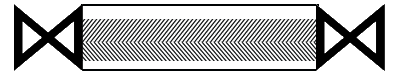
Godzilla nuotò fino alla costa nord-orientale di Oahu e approdò sull’isoletta di Kukuiho’Olua, a qualche centinaio di metri dall’entroterra, dove Alford abitava come un eremita. Certe volte non riusciva proprio a capire se era contento di quella solitudine o se gli dispiaceva. Quando il suo titano appoggiò le zampe sul fondale, Alford sciolse il lasso e remò fino alla sponda. Una volta che scese a terra, la spiaggia fu adombrata di colpo e lui non sentì più il calore del sole. Si voltò e sorrise: Godzilla si era alzato del tutto, torreggiando sulla piccola isola dai suoi trentuno metri di altezza.
Come tutte le volte, Alford non poté fare a meno di prendersi un momento per ammirare il suo compagno di avventure ereditato da suo padre, da suo nonno prima di lui e dal bisnonno prima ancora: non importava quante volte ammirava il suo titano, lo lasciava sempre a bocca aperta. Il padre di Alford gli aveva garantito che non si sarebbe mai sentito abbastanza fiero di avere una creatura simile al suo fianco, quando l’enorme responsabilità del titano della famiglia era passata a lui, e ogni giorno l’Ammazzatitani constatava che era proprio vero.
Godzilla si scrollò l’acqua di dosso con un paio di pigri scossoni e, con uno sbuffo, si incamminò placidamente verso la baia in cui andava sempre a riposare, facendo tremare la terra coi suoi passi. Alford, allora, si riscosse da quel momento di contemplazione e tornò alle sue faccende: era ora di pranzo. Prese la cassa coi tonni dalla botola e scese a terra, quindi si avviò verso il suo modesto e solitario bungalow circolare in legno e paglia in mezzo ad una macchia di palme. La sabbia calda gli scottava le piante dei piedi nudi mentre camminava. Una volta che fu in casa, lasciò la cassa accanto alla soglia e andò ad aprire la credenza in cui teneva il sale, le spezie e i condimenti, accanto alla cucina da campo. Appena aprì lo sportello, però, Alford rimase di sasso: aveva esaurito il sale e gli rimaneva solo mezzo sacco di pepe nero e cumino. Non avrebbe potuto tenere da parte il secondo tonno. Questo non gli lasciava alternative.
“No, dannazione! Non di già!” pensò, scoraggiato.
Era costretto ad andare a Honolulu per fare rifornimento. Questo significava fare i conti con la paura che la gente aveva di lui. O meglio, la paura che avevano di Godzilla e, pertanto, di lui, a causa di tutte le voci che giravano per il mondo sui suoi trascorsi

Alford tornò a passo spedito alla sua barca, la slegò e iniziò a seguire la costa aiutandosi col vento. Quando passò davanti alla baia personale di Godzilla, vide che il suo titano stava già dormendo: riusciva a sentire i suoi profondissimi respiri. Erano già accorsi diversi uccelli, venuti a posarsi in riga sulle placche dell’enorme rettile mentre rimaneva lungo disteso. Di lì a poco, qualche rettile si sarebbe arrampicato su di lui per prendere il sole come sulle rocce. Alford circumnavigò l’isola godendosi la brezza oceanica, fino ad arrivare al porto di Honolulu. Gli attracchi erano aumentati all’inverosimile negli ultimi anni, da quando i viaggi attraverso tutto il globo erano diventati così frequenti. Le grandi nazioni dell’Occidente e dell’Oriente investivano sempre di più nei commerci tra continenti e le Hawaii erano passate da una semplice fermata per chi faceva la traversata del Pacifico a uno di molti punti di incontro insulari tra mercanti e uomini d’affari di tutto il mondo.
Alford era sempre stato affascinato dal fatto che le isole fossero da sempre considerate dei porti franchi: da Capo Verde ai Caraibi, dalla Polinesia alle Hawaii, in quei punti isolati nell’oceano si faceva sempre finta che le grette rivalità e tensioni tra monarchie e imperi vari non ci fossero. A partire dal 1745, cinque anni prima, il fenomeno gli pareva ancora più evidente. Gli era capitato di sentire che uno di quei cosiddetti “illuministi”, nei loro salotti in Francia, aveva scritto in una rivista che il mondo era partito di corsa dopo aver camminato a passo pigro per secoli. A quanto pareva, non aveva torto. Alford non aveva dubbi che questo repentino sviluppo globale fosse dovuto in parte al fatto che le nazioni avevano iniziato a fidarsi sempre di più dei Padroni di Titani come lui e a chiedere loro una mano per accelerare i loro progressi economici e intimidire i regni rivali. I titani erano stati anche utilissimi per spedizioni ed esplorazioni: grazie a loro, il globo era stato mappato per intero in pochissimi anni. I geografi dicevano che, senza quegli interventi, ci sarebbero voluti ancora dei secoli.
Alford si riscosse dalla sua riflessione sull’attualità quando si avvicinò alle decine di vascelli da tutti gli angoli del mondo attraccati a Honolulu: doveva trovare un ormeggio libero tra le barche come la sua. Si aggirò tra galeoni e brigantini, iniziando a sentire il vivace brusio del villaggio; alla fine, trovò un posto libero tra due scialuppe lungo uno dei pontili più esterni. Approdò, legò la sua barca a vela e attraversò il molo preparandosi a trattenere il disagio che lo attendeva: era ora di apparire in pubblico; purtroppo, per quanto autonomo si sforzasse di rendersi, non poteva sfuggire all’inevitabile ritorno alla società che gli toccava ogni tanto. Iniziò a dirigersi verso il mercato per prendere il sale. Lungo il percorso, fiangheggiò un terreno disboscato in cui i contadini fertilizzavano il suolo coi concimi derivati dallo sterco dei titani, ironicamente una merce quasi più pregiata dei metalli preziosi.
Honolulu era ormai in tutto e per tutto un villaggio cosmopolita come tutte le città isolane: oltre ai tradizionali bungalow degli Hawaiani, si trovavano varie locande, botteghe e edifici costruiti dai visitatori dal resto del mondo; era anche possibile suddividere il centro abitato in piccoli “cantoni” in cui si raccoglieva la gente che parlava la stessa lingua. Il contrasto culturale era stato quasi sconvolgente per i nativi delle Hawaii, fino ad alcuni anni prima, ma col tempo era diventata la nuova normalità. Tutti stavano accettando a poco a poco la nuova realtà in cui tutti stavano diventando "cittadini del mondo". Alcuni mercanti e imprenditori avevano cavalcato quell’onda con talmente tanto successo che le loro compagnie erano conosciute dappertutto e avevano almeno una sede in tutti i continenti. E, proprio in quel momento, Alford si accorse di qualcosa che attirò la sua attenzione: in mezzo a un palmeto stavano costruendo una nuova fucina e gli operai stavano issando l’insegna: I Ferri di Franchi.
“Franchi? Alla fine ha raggiunto anche il mio buco” pensò Alford, sarcastico.
Non c’era esploratore, soldato, mercenario o chiunque lavorasse brandendo un’arma che non conoscesse il mercante italiano Luigi Franchi, il padrone della più grande compagnia di fabbri del globo. Aveva la sua sede centrale a Venezia e da lì, nell’arco di dieci anni, aveva fatto una fortuna espandendo la sua attività in tutto il mondo, con la sua competitività feroce e le sue politiche aziendali aggressive. Era il migliore sulla piazza e Alford lo conosceva di persona; ma faceva tutto parte del passato. Il passato che ora gli era costato la sua reputazione.
A quel punto, raggiunse il mercato. Si mise a seguire la strada cosparsa di tende e banconi che radunavano tutte le culture dai sei continenti. La gente discuteva sugli affari, trattava sui prezzi, trasportava oggetti e alimenti lungo la strada, i bambini hawaiani osservavano e ascoltavano curiosissimi i mercanti da terre lontane, alcuni venditori con pochi clienti conversavano e raccontavano storie coi loro vicini di bancarella; tutta quella frenesia e vivacità si congelava per alcuni momenti, all’arrivo di Alford. Alla sua vista, i presenti nativi e non iniziarono a lanciargli occhiate sospettose e diffidenti, quando lo vedevano passare. Cessavano le loro conversazioni o i loro affari per osservare l’Ammazzatitani, i loro occhi passavano dal sorpreso al guardingo e intimorito in un battito di ciglia. Dopodiché, in modo forzato, tornavano a fare quello che stavano facendo, ma ormai erano distratti da lui. Alford sentiva ognuna di quelle occhiate su di sé, le percepiva mentre i loro occhi si puntavano su di lui e non lo lasciavano più andare, come se fosse una mosca in una ragnatela. E gli sguardi aumentavano, si accumulavano, lo schiacciavano come macigni: lo giudicavano. Lo giudicavano e lo condannavano, lui lo sapeva. Lo sentiva dentro di sé; ma, finalmente, trovò quello che cercava: un mercante di sali dall’India. Alford scacciò tutti i pensieri angoscianti dalla testa e si concentrò su quello che doveva fare. Si avvicinò alla bancarella e salutò, cercando di sembrare il più naturale possibile.
«Salve. Ho bisogno di fare scorta di sale»
Si morse la lingua senza darlo a vedere: come al solito, era stato freddo e meccanico. Gli succedeva tutte le volte, il che di certo non lo aiutava con le persone. Il mercante lo fissò sorridente per alcuni attimi, poi sembrò capire chi avesse davanti e rimase di sasso. Restò interdetto, con gli occhi sbarrati e la bocca semi-aperta, per vari secondi, tanto che Alford iniziò a sentirsi in imbarazzo e cercò di smuovere la situazione:
«Mi serve sale per almeno un mese. Devo conservare del pesce»
A quel punto, il venditore si riscosse e farfugliò il prezzo in rupie per un sacco di sale con fare intimidito. Alford disse di non avere rupie, solo corone britanniche. Il mercante reagì come se fosse appena stato minacciato di morte e lo rassicurò sudando freddo che andava bene lo stesso, che si sarebbe arrangiato ad andare da un cambiavalute. Alford annuì, sconfortato dal modo di fare dell’Indiano, e frugò in un sacchetto che aveva portato dal suo bungalow, porgendogli l’equivalente in corone del prezzo. A quel punto ricevé il sacco di sale e iniziò ad andarsene, senza ringraziare né salutare: aveva fatto quello che doveva, ora la sua unica preoccupazione era levare le tende il più in fretta possibile, finché riusciva a sopportare le occhiate. Sapeva bene che il suo atteggiamento lo faceva sembrare uno stronzo, ma non gli importava più da parecchio tempo. Tanto, ormai, lo evitavano a prescindere.
Tornò al molo a passo svelto. La calma del pontile delle barche lo fece sentire liberato da un peso: lì c’erano solo alcuni pescatori che maneggiavano le cime o le reti o conversavano tra loro, si sentiva molto più a suo agio che in mezzo al villaggio. Muovendosi in fretta per farsi notare il meno possibile dai pochi presenti, Alford raggiunse la sua barca a vela e sistemò il sacco di sale nella botola. Era ora di tornare da Godzilla e godersi finalmente il pranzo. Ma, mentre si preparava a sciogliere la cima, sentì dei passi sul legno dietro di sé e il gracchio di un pappagallo. Poi una voce allegra lo chiamò:
«Ehi, tu! Il tizio dei titani, giusto?»
Perplesso, Alford si voltò e vide un giovane uomo hawaiano a petto nudo dal fisico in ottima forma, coi capelli lunghi, un pizzetto, dei tatuaggi sul braccio sinistro e un sorrisetto spiritoso stampato in faccia. Posata sulla sua spalla, c’era un’amazzone dalla corona rossa, un pappagallo verde originario delle Hawaii. L’approccio del ragazzo stupì Alford al punto da disorientarlo: cos’era quel tono scherzoso, quasi di sfida? Come doveva interpretare quell’espressione spensierata? Non sapeva chi avesse davanti? No, impossibile: ormai tutti alle Hawaii lo conoscevano di volto e di nome. Quindi perché non lo evitava e disprezzava come tutti? Guardandolo bene, però, Alford intuì che quella faccia era forzata: stava solo fingendo di essere così disinvolto. Quindi, sotto la superficie, anche lui era intimorito come gli altri; ma allora perché era venuto da lui? Non si rese conto di essersi perso nelle sue riflessioni finché la smorfia del ragazzo non si spense poco alla volta, lasciando il posto a un’espressione genuinamente perplessa.
«Ehi, ti sei incantato? Sei quello che va in giro a scannare titani o no?» gli chiese.
Alford cercò ancora un po’ di provare a intuire che intenzioni avesse quel tipo, prima di riuscire a elaborare una risposta diffidente:
«Sì. Sarebbe “l’Ammazzatitani”»
Il sorrisetto ritornò sulla faccia dell’Hawaiano:
«Oh, allora sai parlare! Io sono Kilani» si presentò.
Alford tacque un secondo, prima di decidere di assecondare quel tentativo di conversazione: non gli capitava un’occasione come quella da anni, valeva la pena godersela.
«E io sono Al…»
Fu interrotto dal pappagallo di Kilani che, di punto in bianco, gracchiò:
«Craaaaaaa! Bella signorina! Bella signorina!»
Kilani trasalì e strabuzzò gli occhi, diventando subito paonazzo. Alford rimase a bocca aperta, più confuso che mai, chiedendosi sul serio se aveva capito bene quello che aveva appena sentito. Credé davvero che l’uccello si riferisse a lui, prima di notare che sia l’amazzone che il suo padrone stavano guardando oltre le sue spalle. Si girò, incuriosito, e vide una giovane ragazza che fissava Kilani con uno sguardo colmo di disagio. Era seduta sul pontile per fissare l’orizzonte, ma si alzò subito e si allontanò facendo finta di nulla. Alford, davanti a quella scena, non poté fare a meno di lasciarsi sfuggire un sorriso divertito. Tornò a guardare Kilani, che si stava coprendo gli occhi con una mano. Poi guardò il suo pappagallo e lo rimproverò scherzosamente:
«Ma che fai? Così mi fai fare brutta figura! Davanti al tizio dei titani, poi! Hai imparato a fare il trucco, ma non a scegliere il momento, eh?»
Alford, intanto, lo fissava senza proferire parola, indeciso su cosa dire o se fosse anche solo il caso di fare un commento. Quel momento era già imbarazzante di per sé, non gli sembrava il caso di peggiorare la cosa. Si sentiva più a disagio ogni secondo che passava. Quando Kilani se ne accorse, fece una faccia da ebete per un rapido istante, per poi tentare in fretta e furia di giustificarsi, rimettendo subito la maschera di sicurezza che aveva all’inizio:
«Eh, sai com’è, “Al”… non si sa mai chi la prende bene, chi la prende male e chi ha un padre geloso, così lascio il lavoro sporco a lui! Se lo dice un pappagallo, nessuna si offende: anzi, funziona meglio perché le fa ridere!»
Alford continuò a tacere, iniziando a considerare l’idea di ignorarlo, salpare e fare finta di niente, come aveva fatto la ragazza. Kilani si affrettò a continuare a difendersi:
«Eddai, questa era una cilecca sfortunata! Tutte le altre volte funziona, è un metodo garantito»
Finalmente, Alford riuscì a decidersi e rispondergli:
«Non ne dubito. Hai bisogno di qualcosa?» chiese, andando subito al punto.
Notò che Kilani aveva tirato un sospiro di sollievo, anche se cercava di non darlo a vedere: si era salvato dalla gaffe imbarazzante, quindi recuperò la sua compostezza. Stavolta, però, si fece più serio:
«A dire la verità, tutte le Hawaii hanno bisogno di aiuto, soprattutto noi pescatori di Ohau. Solo che tutti i miei compagni hanno troppa paura di te, così mi hanno chiesto di andare a chiederti un favore. Li capisco bene, in fondo nessuno resiste al mio carisma» ridacchiò.
Dentro di sé, Alford era pronto a scommettere che i pescatori dell’isola avessero mandato il più scemo, sapendo che non si sarebbe fatto problemi a parlare con lui. Ma non vedeva alcun motivo per lamentarsene; a quel punto, anche quel palese dongiovanni gli andava benissimo, se signficava non essere trattato come il demonio. Riflettendoci bene, se aveva capito l’antifona, quella era un’opportunità preziosa come l’oro: se gli avessero chiesto un aiuto importante e lui si fosse reso utile, forse avrebbe potuto fare qualcosa per dimostrare agli Hawaiani che, in realtà, non avrebbe mai fatto del male a nessuno. D’altronde, un po’ era anche colpa sua se, da quando aveva cambiato vita, non aveva mai svolto neanche un “lavoro” da quelle parti, ma solo in posti troppo lontani perché la notizia arrivasse fin lì. E così, spinto da quella speranza di ripulire la sua reputazione sulle “sue” isole, scese dalla barca e tornò sul pontile, incrociando le braccia e guardando Kilani con attenzione:
«Ti ascolto» si limitò a dire.
Allora Kilani gli si avvicinò, facendo crescere a dismisura il disagio di Alford, e gli sussurrò come se stesse per confidargli un segreto:
«Prima di tutto, giusto per sicurezza… non sei tu che ci stai rubando tutti i pesci, vero? Sai com’è, credo che un bestione come il tuo debba mangiare tanto»
«Ehm… cosa?» domandò Alford, più confuso che mai.
Kilani gli rivolse un’occhiata inquisitoria talmente esagerata da essere quasi caricaturale, prima di scoppiare a ridere:
«Ahahaha! Rilassati, ti stavo solo mettendo alla prova! Si vede che non hai idea di cosa parli, quindi sei innocente»
«Godzilla mangia solo balene, quando non assorbe l’energia da sottoterra» spiegò Alford, con naturalezza.
Kilani strabuzzò gli occhi:
«Ah! Caspita. Lo dicevo che deve mangiare tanto. Vabbè. Il fatto è questo: ormai è da una settimana che nessuno riesce più a portare a casa un pescato decente. È una fortuna se riusciamo a prendere uno o due pesci nelle reti!»
Alford era molto intrigato: allora la sua pesca scarsa degli ultimi tempi non era stata una sua sfortuna, tutte le Hawaii stavano attraversando un periodo di magra inaspettata. I mari dell’arcipelago erano sempre stati molto pescosi, specialmente in quel periodo dell’anno, quindi una scomparsa improvvisa di tutto il pesce poteva significare solo che c’era una moria o qualcosa che li faceva scappare tutti. E in natura c’era solo una cosa che potesse provocare questi squilibri in natura: un titano.
«Un titano si è fermato qui e ha iniziato a mangiare tutti i pesci» affermò, quasi pensando ad alta voce.
Kilani schioccò le dita e annuì:
«Sì! È quello che abbiamo pensato subito anche noi! Allora ci siamo riuniti per decidere cosa fare e abbiamo subito pensato a te: sappiamo che sei famoso perché dove passa il tuo amicone i titani tagliano la corda. E quindi eccomi qua. Allora, che ne dici? Insomma, è un problema anche per te: tutti abbiamo bisogno di pescare! Sarebbe un vantaggio per tutti»
Questo era innegabile. Ma era anche il momento di mostrare a tutti la vera natura del nuovo Ammazzatitani. Quindi Alford annuì:
«È vero. Vi aiuterò»
Kilani sorrise, raggiante:
«Fantastico! Passiamo subito alla nota dolente: cosa ti dovremo, in cambio?»
Di solito, quella domanda era l’unica parte davvero importante di un ingaggio, per Alford. La risposta cambiava sempre: a volte gli serviva solo l’ospitalità di una comunità per qualche settimana, a volte doveva rimpinguare i suoi soldi ma, in quell’occasione, aveva un nuovo scopo: fare bella figura. E poi, anche se persino una parte di lui la trovava una scemenza filosofica, l’eventuale riconoscenza degli isolani sarebbe stata tutto quello che gli serviva. Tanto avrebbe dovuto provvedere da solo a pescare, dopo che i pesci sarebbero tornati. Così alzò la mano e scosse la testa:
«Non vi preoccupate, questa disinfestazione ve la farò gratis»
Kilani parve non crederci:
«Però, è molto altruista da parte tua. Sul serio, quanto o cosa vuoi?»
«No, no, sono serio: non voglio niente. In questo caso, conta solo riportare i pesci, allora non mi servirà un pagamento per andare a prenderli»
Preferì trovare una scusa concreta: sarebbe stata molto più credibile della storiella della gratitudine. Kilani fu indeciso per qualche secondo, ma alla fine si convinse e fece spallucce:
«Contento tu, contenti noi. Affare fatto!»
Anche il suo pappagallo sembrò contento, perché emise un paio di gracchi vivaci e si scrollò le piume. L'Ammazzatitani e l'Hawaiano fecero per stringersi la mano per siglare l'accordo, ma furono interrotti all'ultimo secondo da grida ed esclamazioni da tutto il porto. Perplessi, si guardarono intorno e si accorsero che tutti i presenti sui pontili e a bordo dei vascelli stavano osservando l'oceano, spaventati e sconvolti. Dopo essersi scambiati uno sguardo allarmato, si voltarono verso il Pacifico e sobbalzarono, alla vista di quello che stava succedendo al largo: a qualche centinaio di metri della costa di Oahu, un brigantino stava venendo risucchiato sott'acqua. Il mare tutt'intorno al vascello spumeggiava e girava furiosamente in cerchio, intrappolando la nave in un ampio mulinello che le impediva di allontanarsi e che la trascinava sempre più in fretta nelle profondità. Nel giro di pochi minuti, davanti agli sguardi sconvolti e impauriti dei marinai e degli abitanti di Honolulu accorsi per guardare la scena, il brigantino si rovesciò su un fianco e fu inghiottito del tutto dall'oceano, che smise di vorticare e ribollire pochi istanti dopo. All'improvviso, fu come se quella nave non fosse mai stata lì. Era stata portata negli abissi, con tutto il suo equipaggio e il suo carico, da un momento all'altro. Dalla folla che si era radunata in fretta al porto, si sollevò un gran trambusto carico di panico e sgomento. Kilani rivolse uno sguardo preoccupato e stravolto ad Alford:
«Maledizione! Questo è... è stato...»
Presumendo che stesse per chiedergli cosa fosse stato, Alford gli rispose:
«Sì, era per forza il titano che ha spaventato i pesci. Non c'è dubbio: ha stabilito il territorio, adesso penserà anche a difenderlo, non solo a cercare il cibo. Nessuno sarà al sicuro al largo, finché starà qui»
«Devi fare qualcosa! Non possiamo permettere che succeda di nuovo!» esclamò Kilani, serio, indicando l'oceano.
L'Ammazzatitani annuì:
«Assolutamente. Questo problema va ben oltre la pesca. Vado dal mio amico e inizio subito la caccia: non c'è tempo da perdere» affermò, determinato.
«Bene. Buona fortuna, Al!» lo incoraggiò Kilani, prima di allontanarsi a passo svelto.
Alford borbottò un ringraziamento e sorvolò su quel nomignolo su cui ormai Kilani si era fissato, saltando sulla sua barca e slegando le cime. Uscì dal porto di Honolulu e iniziò la rotta di ritorno alla sua piccola isola, stando il più vicino possibile alla costa. Godzilla doveva intervenire subito: quella faccenda si era rivelata molto più grave di quanto sembrasse. Non poteva lasciare che altri marinai venissero uccisi dal misterioso titano che aveva fatto dell'arcipelago il suo territorio di caccia: era il momento che l'Ammazzatitani agisse e desse prova del suo titolo.
Chapter Text
Godzilla fu riscosso dal suo placido torpore dalla voce di Alford che lo chiamava a pieni polmoni. Aprì gli occhi con pigrizia e vide il suo padrone di ritorno, con la barchetta. L’uomo gli stava facendo segno di raggiungerlo con ampi gesti delle braccia. Con uno sbuffo, il titano si sollevò sulle ginocchia e con le zampe anteriori e iniziò a strisciare verso l’oceano a quattro zampe. Sentì gli stridii spaventati di tutti gli uccelli che si erano posati sulla sua cresta mentre dormiva e li scacciò con uno scrollone. Raggiunta l’acqua, gattonò sul fondale per un breve tratto, prima di iniziare a nuotare. Si accostò con calma alla barca e attese che Alford la agganciasse alle sue placche. Il suo padrone lanciò il lasso e lo assicurò alla cresta del titano. A quel punto, alzò le braccia sopra la testa, strinse il pugno e lo pestò contro il palmo dell’altra mano; Godzilla riconobbe subito quel segno.
«Abbiamo un nuovo lavoro, amico mio: c’è un titano da togliere di mezzo» annunciò Alford.
Il Gojirasauro rispose con un gorgoglio. Alford sollevò ancora il braccio, per poi puntarlo verso Oahu. Il titano seguì l’indicazione e iniziò a nuotare a passo spedito in direzione dell’isola principale. Alford gli fece seguire la costa di Oahu finché non si ritrovarono davanti al porto di Honolulu. Godzilla lanciò una rapida occhiata curiosa alla città: vide i minuscoli umani andare avanti e indietro fra le costruzioni e le navi approdare, il che gli fece piacere: gli aveva sempre dato fastidio stare attento a non speronarle, le volte in cui era costretto a nuotarci in mezzo. All’improvviso, però, tutti gli abitanti di Honolulu iniziarono a radunarsi in riva al mare, man mano che si accorgevano di lui.
«Sembra che stavolta avremo un pubblico. Cerchiamo di non spaventare nessuno, va bene?» disse Alford.
L’uomo indicò il mare aperto, per comunicargli di non avvicinarsi troppo al porto. Godzilla obbedì e si allontanò dalla costa. A un certo punto, Alford fece un breve fischio e il titano si fermò. Osservò il padrone slegare la barca dalla sua cresta, quindi si posizionò davanti alla prua per attendere gli ordini. L’uomo alzò un braccio e, tenendo l’indice sollevato, lo fece roteare sopra di sé: gli stava dicendo di perlustrare la zona.
«Qui il titano ha affondato una nave. Forse è ancora qui sotto. Cercalo!» esclamò.
Godzilla emise un verso gutturale, prima di dilatare le branchie e immergersi. Iniziò a scendere verso il fondale con forti sferzate della coda. Più scendeva, meno luce arrivava, ma non era un problema: era abituato ad abissi molto più profondi. Arrivato al fondale sabbioso, iniziò a perlustrarlo, nuotando a spirale. I pochissimi raggi del sole che arrivavano fin laggiù illuminavano poco o niente, ma i suoi occhi vedevano le profondità intorno a lui senza problemi. Godzilla si guardava in giro e rimaneva in ascolto: aspettava di cogliere un segnale. Un gemito, un richiamo, un verso intimidatorio, qualunque cosa.
Finalmente, scorse ciò che stava cercando: a qualche centinaio di metri di distanza, un titano lunghissimo e sinuoso era avvolto intorno a un relitto, con la testa infilata nello scafo. Si contorceva e agitava con frenesia: si stava ingozzando del contenuto della nave. Aveva due larghe pinne frontali; per il resto, non aveva arti. Tutta la schiena era percorsa da una vela ampia e sottile, che si piegava e ondeggiava coi movimenti dell’acqua. Il lungo corpo da verme terminava con una grossa coda palmata. Era un Tiamat.

Godzilla iniziò a nuotare a tutta velocità verso il bersaglio, ancora ignaro del suo arrivo. Aprì le fauci e protese le zampe in avanti, pronto ad afferrarlo. Prima che il Tiamat si accorgesse di nulla, lo travolse in pieno. Serrò la mandibola sul corpo della preda e la tenne stretta a sé con gli artigli. Il Tiamat, colto di sorpresa, cercò di dimenarsi, ma la presa del suo aggressore era troppo forte. Emise un ticchettio che fece eco per l’abisso, si avvolse subito intorno al corpo di Godzilla e iniziò a stringerlo tra le sue spire. Godzilla fu costretto a buttare fuori quasi tutta l’aria che aveva da quella potente stretta e lasciò la presa. Le scaglie taglienti del Tiamat iniziarono a incidere la sua corazza, ma non era nulla che Godzilla non potesse sopportare.
Cercò di torcere la testa per prendere il collo del Tiamat. Non appena il serpente marino gli rivolse un sibilo minaccioso, Godzilla gli afferrò la gola con una zampa e tentò di staccare le spire dal suo petto con l’altra. Il Tiamat resisté per una manciata di secondi ma, quando Godzilla strinse la presa sulla sua trachea con tutte le forze, dové cedere e lo lasciò andare. Dai taglietti sparsi dove il Tiamat aveva stritolato Godzilla, fuoriuscirono piccoli rivoli di sangue. Il serpente marino morse la zampa anteriore di Godzilla, in preda al panico. Per tutta risposta, il Gojirasauro nuotò verso l’alto senza mollare la presa, trascinando la preda con sé; dopodiché, puntò di nuovo il fondale marino e scese di scatto. Subito prima di raggiungere il fondo, vi sbatté contro la testa del Tiamat.
Il serpente marino rimase stordito dall’impatto. Godzilla ne approfittò per arretrare e fare di nuovo scorta di aria. Aprì al massimo le branchie e incamerò tutto l’ossigeno che poteva, per poi espellere l’acqua dalle narici. Dopo un attimo di immobilità, il Tiamat si riprese e prese le distanze. Si attorcigliò su se stesso, in posa difensiva, e sibilò facendo vibrare i filamenti che partivano dal suo muso. In quel momento, Godzilla si accorse che la sua preda aveva uno strano rigonfiamento sotto la metà inferiore del suo corpo, come se avesse una vescica sulla pancia. Il Gojirasauro gorgogliò, incuriosito: era una sacca di uova. Ecco perché non era aggressivo come i Tiamat che aveva già ucciso in vita sua: stava proteggendo la sua prole.
Godzilla rispose al sibilo con un ringhio e tornò alla carica: stavolta, aveva intenzione di tranciarlo a metà. Però, appena si avvicinò alla preda, il Tiamat reclinò il collo all’indietro e sputò una nube giallastra sul muso del suo aggressore. Di colpo, Godzilla avvertì un bruciore negli occhi e su tutta la testa: era stato colpito con l’acido. Interruppe di colpo il suo assalto e nuotò lontano dalla nuvola corrosiva, scrollando il capo con vigore per lavarsi dall’acido. Quando il dolore passò, Godzilla riaprì gli occhi e si guardò intorno. Vide il Tiamat scappare via, serpeggiando nell’acqua con l’aiuto della coda. Il lucertolone sapeva che non l’avrebbe potuto raggiungere: era troppo agile e veloce, in confronto a lui.
Con un gorgoglio irritato, Godzilla iniziò a risalire con calma. La luce ritornò a poco a poco, come era scomparsa dopo l’immersione, e l’acqua passò da nera ad azzurra. A pochi metri dalla superficie, Godzilla si ritrovò faccia a faccia con Alford, immerso all’altezza del naso del suo titano. Il suo padrone gli si avvicinò, lo guardò negli occhi e incrociò le braccia, come una X: il segno che la caccia era finita.

Alford tornò in superficie e inspirò a fondo. Godzilla emerse con calma dietro di lui e spruzzò acqua dalle narici, facendogli una doccia di muco e salsedine. L’uomo lanciò un’occhiata indispettita al suo titano e si sciacquò la faccia, prima di tornare alla sua barca a vela. Si issò a bordo e si sedé a poppa, per riprendere fiato e asciugarsi. Mentre il sole gli scaldava la pelle bagnata, Alford osservò la costa di Honolulu, riparandosi gli occhi con una mano: la calca li stava guardando in religioso silenzio, senza muoversi. Era come se aspettassero un verdetto. Alford si concesse un sorriso soddisfatto e sollevato: non rimaneva altro che comunicare la buona notizia. Di colpo, sentì una voce familiare che lo chiamava alle sue spalle:
«Ehi, Al! Che succede?»
Era Kilani. Alford si girò sull’asse della poppa e vide il pescatore hawaiiano che si avvicinava su una canoa; lo stava salutando con la mano. Alla sua vista, Godzilla inclinò il capo con uno sguardo incuriosito. Alford attese che Kilani si accostasse alla sua barca, per poi alzarsi e rispondere alla domanda:
«Abbiamo risolto il problema. I pesci dovrebbero tornare nei prossimi giorni»
«Fantastico, ma puoi dirmi qualcosa di più? Insomma, cos’è stato ad affondare il brigantino, prima?»
«Era un Tiamat; un maschio con le uova»
Kilani fece un espressione confusa:
«Aspetta, cosa? Se aveva le uova, non dovrebbe essere una femmina?»
Alford alzò una mano e scosse la testa:
«No, era un maschio. È così che fanno: le femmine depongono le uova, i maschi le raccolgono»
L’Hawaiiano lo ascoltava tenendosi il mento fra il pollice e l’indice, affascinato:
«Interessante! È strano, ma chi sono io per giudicare la natura?»
«Comunque, era venuto qui perché c’era cibo in abbondanza per lui e per i piccoli. Si nascondeva sul fondale e non mandava segnali, per questo Godzilla non se n’è mai accorto»
«E dov’è il Tiamat, adesso? Il tuo amicone l’ha ucciso?»
Alford lo rassicurò:
«Non ce n’è stato bisogno: è scappato. Ora che sa che queste isole sono il territorio di Godzilla, non oserà più tornare. Non dovrete più preoccuparvi per il pescato»
Kilani fece un sorriso allegro:
«Perfetto! Saranno tutti contentissimi di saperlo! Perché non torni a riva con me e glielo dici di persona? Non hai voluto niente in cambio, almeno prenditi la gloria. Possiamo improvvisare un festino per te, noi pescatori!»
Dapprima, Alford fu felice di quell’invito. Poi, però, fu assalito da un dubbio: l’offerta non veniva dalla gente di Honolulu, veniva solo da Kilani, che gli aveva dato l’impressione di essere un tipo che “si distingueva” dal resto del gregge. E se fosse saltato fuori che tutti gli altri non volevano davvero festeggiarlo? Ormai si era abituato alle trattative fredde e tese dei suoi clienti, in giro per il mondo. Non conosceva altra forma di riconoscimento, se non i ringraziamenti di circostanza da parte della gente che lo guardava con timore. E se anche gli avessero davvero fatto una festa, la gratitudine sarebbe stata sincera o solo una facciata, giusto per metterlo a suo agio? Alla fine, in un lampo di determinazione, decise di non tirarsi indietro: se voleva che la gente cambiasse idea su di lui, doveva pur fare il primo passo. Ma non prima di aver sistemato l’ultima faccenda in sospeso della giornata.
«Grazie molte per l’offerta! Non mi hanno mai fatto una festa» rispose quindi.
Kilani fece un sorrisone allegro:
«Benissimo! Vieni con me, allora: ti presento agli altri»
«È un problema se ti raggiungo dopo?» chiese Alford.
«Perché dovresti?»
«Quando sei venuto a parlarmi, avevo comprato il sale per conservare il pesce. Vorrei mettere via il pescato, prima di fare qualunque altra cosa. Non vorrei che andasse a male» spiegò l’Ammazzatitani.
Kilani annuì, comprensivo:
«Oh, ma certo. Poco male: ne approfitteremo per allestire tutto mentre ti aspettiamo. A dopo!»
I due marinai, a quel punto, si congedarono. Mentre Kilani remava verso la costa, Alford assicurò di nuovo la barca a vela alle placche di Godzilla e gli ordinò di tornare alla loro isoletta. Non era stato così soddisfatto da anni.
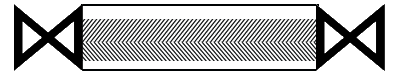
Dopo che Godzilla fu approdato a Kukuiho’Olua, Alford arenò la barca a vela sulla spiaggia e si avviò verso il suo bungalow col carico di sale in spalla. Allegro per gli ottimi risultati che aveva ottenuto col Tiamat, aveva preso a fischiettare un motivetto esotico che aveva imparato da sua madre quando era piccolo e non riusciva più a toglierselo dalla testa. Gli succedeva tutte le volte che era contento. A un certo punto, però, si accorse di un dettaglio che lo allertò: nella sabbia, c’erano impronte umane diverse dalle sue, che entravano in casa sua.
“Chi cazzo viene sulla mia isola?” pensò, stupito.
Si spostò i sacchi di sale sottobraccio e si avvicinò alla soglia con fare cauto, a passi leggeri. Quando entrò nel bungalow, vi trovò un uomo anziano con la pelle olivastra e folti capelli grigi e riccioluti che gli dava le spalle, intento a fissare una mappa delle Hawaii appesa al muro con le mani sui fianchi. Alford capì subito di chi si trattava e si sorprese al punto che lasciò cadere i sacchi, quasi senza accorgersene. Il vecchio sobbalzò per il rumore improvviso e si voltò, mostrandogli il suo volto grinzoso, la sua lunga barba curatissima e i suoi occhi marroni ancora vispi.
«Argh! Oh! Sei arrivato!» esclamò, con un sorriso.
Alford rimase immobile a fissarlo per qualche secondo, come ipnotizzato. Poi riuscì a riscuotersi e domandò:
«Philippos? Che ci fai qui?»
Il vecchio gli sorrise e allargò le braccia:
«Ti direi, caro Alford, che ci tenevo a farti visita, ma conoscendoti, non mi crederesti»
«Già» mormorò l’Ammazzatitani.
«Come immaginavo. Ergo, ti propongo una risposta che, di sicuro, troverai più consona: i miei onorevoli colleghi Sapientes pretendono dal sottoscritto un rapporto sulle tue attività negli ultimi due anni, un compromesso che sono riuscito a ottenere quando ho rimarcato che tenerti sotto osservazione per tutto il tempo sarebbe stato uno spreco di tempo e risorse. Sei soddisfatto?»
Alford ci rimuginò un po’ sopra, poi fece spallucce:
«Immagino che abbia senso. Sai, capiti proprio al momento giusto»
Philippos si mise le mani dietro la schiena, con un sorriso affabile:
«Hai buone notizie?»
«Ho affondato dei pirati da quattro soldi e ho scacciato un Tiamat che aveva spaventato tutti i pesci di queste isole. Tutto oggi»
Philippos frugò nella bisaccia che aveva a tracolla; ne tirò fuori della carta, un calamaio e una penna d’oca. Si appoggiò alle casse che Alford usava come credenze e iniziò a scrivere.
«Che stai facendo?» chiese l’Ammazzatitani.
Philippos lo guardò come se gli avesse fatto la domanda più scontata del mondo e rispose:
«Faccio rapporto, come dicevo. Dimmi, il Tiamat era il bersaglio di uno dei tuoi “servizi civili”?»
«Cosa?»
«Una caccia su commissione. Insomma, la tua occupazione da quando ti sei costituito»
«Oh! Sì. Mi hanno ingaggiato i pescatori di Honolulu»
«Eccellente. Queste informazioni gioveranno molto alla tua immagine, tra i Sapientes» promise il vecchio.
«Sì, come no» borbottò Alford, a braccia incrociate.
Philippos annuì a occhi chiusi:
«Certo che sì! Fidati di me. E ti posso garantire che, col sussistere di questa condotta, molto presto richiamerai l’attenzione degli altri Padroni di Titani su di te; in senso positivo, intendo»
A quelle parole, Alford fece una risata nervosa e si strofinò il collo, imbarazzato:
«Per favore, Phil, rimani coi piedi per terra: quelli come me non potrebbero mai vedermi di buon occhio»
Il vecchio fece una risatina maliziosa:
«Se la vuoi porre in questi termini, ti informo che fino a duecento anni fa nessuno considerava “quelli come te” persone come tutte le altre, eppure eccoci qua»
Alford non disse più nulla. Incrociò le braccia e osservò Philippos, in attesa che finisse di scrivere. Quando il vecchio terminò il rapporto, arrotolò la carta e mise via penna e calamaio. Così, finalmente, Alford poté mettere via i due tonni che aveva pescato quel giorno. Una volta finito, si appoggiò al muro con la schiena e lanciò un’occhiata diffidente a Philippos, per poi chiedergli:
«Ci sono altri motivi per cui hai attraversato due oceani per vedermi?»
«C’è bisogno che ce ne siano?»
«So già che ci sono, ormai ti conosco»
Philippos alzò le mani e confessò:
«D'accordo, è evidente che mi hai scoperto. Sono giunto fin qui per garantire la tua partecipazione a un evento di primaria importanza, ormai prossimo»
Alford sbarrò gli occhi, sorpreso:
«Cosa c’entro io con gli eventi di voi studiosi, scusa?»
Philippos andò alla finestra del bungalow e si mise a fissare l’oceano con le mani dietro la schiena. Cominciò a spiegare:
«Alford, comprendo per certo che ritieni di non poter causare ulteriori danni, se ti mantieni isolato dai continenti e dalle grandi nazioni, ma ho intenzione di essere sincero con te: mi duole vederti condurre la tua vita in questo modo»
«Non dispiacerti: a me sta più che bene. E Godzilla adora questo posto, quindi siamo entrambi a posto»
«Tuttavia, suppongo che tu sia ben cosciente del fatto che con questa strategia non sarai in grado di affrontare la causa prima che ti ha condotto a questa situazione. Ora non tentare nemmeno di illudermi: siamo entrambi a piena conoscenza del problema al quale sei costretto a far fronte»
«Ah sì? Sentiamo: qual è il mio problema?» lo sfidò Alford.
«Le amicizie sbagliate, com’è ovvio»
All’improvviso, Alford ebbe l’impulso di ridere e non fu in grado di trattenersi; scoppiò in una risata così isterica che si piegò in due: era l’idiozia più esilarante che avesse mai sentito prima. Andò avanti così a lungo che gli venne il singhiozzo. Fu costretto a sedersi e fare lunghi respiri profondi per calmarsi, anche se ogni tanto gli capitava ancora una risata sommessa. Vide che Philippos era rimasto interdetto, con un’espressione colma di imbarazzo e disagio. Il vecchio chinò lo sguardo e fece un sospiro mesto:
«Molto bene, ciononostante ero sicuro di aver decifrato alla perfezione la tua persona»
Alford lo confortò in tono sarcastico:
«Spezzo una lancia a tuo favore: potrebbe crederlo chiunque»
Philippos si ricompose e, con uno sguardo risentito, replicò:
«Ciò non toglie che la mia idea non può che giovarti»
«Ora sono curioso di saperlo. Di che si tratta?»
«Sei venuto a sapere della dipartita del nostro compianto Magister Sapientium?»
«No. Le notizie arrivano tardi qui e me ne perdo parecchie»
«Come era intuibile. Veniamo a noi: tra una settimana si terrà un raduno di tutti i membri dell’associazione nella nostra sede alle isole Azzorre, in occasione della nomina del nuovo Magister Sapientium. Durante i preparativi, sono stato informato da diversi miei associati che l’invito all’evento è stato recapitato a tre dei Padroni di Titani a noi affiliati. Pertanto, ho deciso di presentarti alla squadra, Alford. Ritengo che ciò possa condurci a risultati vantaggiosi tanto per i tuoi interessi, quanto che per quelli dell’associazione»
A quella rivelazione, Alford si allarmò subito. Presentarsi ad altri Padroni di Titani? Tre, per giunta? Non c’era verso che finisse bene, se fosse successo. Ormai l’Ammazzatitani era l’immagine di una minaccia senza cuore, tra le genti del mondo. Mentre le masse erano “soltanto” impaurite in sua presenza, i Padroni di Titani non solo lo temevano: lo odiavano. Alford sapeva bene che molti di loro erano sempre stati indifferenti gli uni agli altri o avevano rivalità personali; eppure, con grande ironia, in breve tempo erano stati tutti unificati dal grande nemico comune: l’Ammazzatitani, colui che poteva portar loro via ciò che li rendeva superiori ai comuni mortali e privarli della loro identità. Chissà cosa si dicevano sul suo conto? Cosa gli avrebbero fatto, se avessero avuto l’opportunità di farlo prigioniero? L’Ammazzatitani fu scosso da un brivido, al solo pensiero. Fu proprio questo timore a dargli la determinazione di scuotere la testa e replicare a Philippos nel tono più secco in cui avesse mai parlato:
«Scordatelo» sentenziò.
Philippos fece un sorrisetto compiaciuto:
«Sapevo che avresti reagito così, infatti ci tengo a farti notare che in tutto ciò non ho mai chiesto la tua opinione al riguardo»
Alford lo fulminò con lo sguardo:
«Sul serio? Pensi davvero di costringermi? Auguri»
Il vecchio fece spallucce:
«Confido che, dentro di te, il tuo desiderio di riscattarti basti per farti smettere di giocare all’eremita cupo»
Alford chiuse gli occhi e sospirò. Decise di essere del tutto onesto:
«Hai ragione, in fondo mi piacerebbe tanto riparare ai danni che ho fatto. Ma non credo nei miracoli. Anzi, sono convinto che quando così tante persone ti odiano in questo modo, nessuna buona azione possa cambiare il loro parere»
«Non potrai mai sapere se sei davvero così irredimibile, se non fai neppure un tentativo. Fidati di me: i nostri tre ospiti sono già stati informati per tempo della tua presenza, il che li ha dissuasi dal partecipare, almeno in un primo momento. Tuttavia, sono riuscito a persuaderli a concederti una possibilità»
Quando sentì quella notizia, Alford sbarrò gli occhi: non riusciva a crederci.
«Non ci casco, mi stai raccontando fesserie per convincermi. Sai cosa penso? Non hanno la minima idea che sono coinvolto e i loro Titani mi salteranno addosso appena Godzilla farà capolino dal mare. Ci scommetto le palle, Phil!»
Il vecchio si mise i pugni sui fianchi, con un’espressione indignata:
«Osi credere che l’unico Sapiens che sia mai stato al tuo fianco menta? Hai visto quanto so essere persuasivo! Quando ti consegnasti, l’intero consiglio voleva che sparissi dalla faccia della Terra. Eravamo tutti intorno a te come il pubblico del Colosseo e…»
Alford lo interruppe con uno sbuffo:
«Phil, ero lì, non devi raccontarmi la storia»
L’anziano Sapiens alzò gli occhi al cielo e tagliò corto:
«Domando scusa per essermi lasciato trasportare. Sembrava che tu fossi condannato, eppure cosa feci prima della sentenza? Presi la parola, dimostrai che il tuo pentimento era sincero e argomentai i non pochi vantaggi che reintegrarti come uno dei nostri Padroni di Titani affiliati avrebbe comportato. Mi presi la responsabilità di agire come il tuo supervisore e giurai che avrei pagato le conseguenze di un mio eventuale fallimento. Cosa ottenni quel giorno? Ti assicurai un accordo con noi Sapientes, la libertà di andare dovunque tu voglia finché assisti la società con Godzilla e un’occasione per riscattarti»
Alford fece un sorriso mesto:
«E per questo non ti ringrazierò mai abbastanza. Il fatto è che ora faccio le stesse identiche cose che ho fatto per anni: ammazzo Titani. Cambia solo il motivo»
«E a te pare poco? Salvi le vite di centinaia di persone ogni anno! Non è forse una bella sensazione, fare parte dei Padroni di Titani che sostengono le comunità? Sei sulla strada giusta, ragazzo mio, ma è ora di fare il primo vero passo. Sai perché credi di fare sempre le stesse cose? Perché ti sei convinto di ciò che tutti quanti credono ancora: di essere un mostro che si è messo a fare buone azioni. Devi venire alle Azzorre e dimostrare che non è così, se vuoi che il mondo veda Alford e non l’Ammazzatitani!»
L’ultima esclamazione scosse Alford nel profondo dell’anima. Lasciarsi alle spalle l’Ammazzatitani e tutto ciò che quel titolo rappresentava e guardare al futuro solo come se stesso? Non c’era niente che chiedesse di più. Ma gli era sempre parso un sogno irrealizzabile, un traguardo che si allontanava sempre di più, non importava quanto si sforzasse per inseguirlo. Almeno, fino all’esortazione di Philippos. Doveva tutto al vecchio Sapiens greco: la libertà, la sua nuova vita e, adesso, quell’occasione irripetibile. Valeva la pena correre un rischio del genere?
Philippos lo fissava con uno sguardo colmo di aspettativa, in attesa di una risposta. Alford non gliela diede. Si incamminò e raggiunse la finestra del bungalow, quasi ignorando il suo ospite. Si sporse dal davanzale e scrutò l’oceano, in cerca di Godzilla. Vide la cresta del suo amico al largo, che solcava le onde lungo la costa della piccola isola. In un momento di fantasticheria, Alford chiuse gli occhi e vagò con la mente. Immaginò se stesso in piedi sulle spalle di Godzilla, davanti a una folla. Ai loro piedi, giaceva la carcassa di un Titano morto, come al solito. Questa volta, però, la gente non lo guardava ammutolita e tesa: era sollevata e rassicurata dalla sua presenza. Quel sogno avrebbe potuto diventare realtà, se avesse convinto tutti che non voleva fare del male a nessuno. Non poteva restare prigioniero della paura e del giudizio, non più. Alford aprì gli occhi e fece un respiro profondo.
«Ebbene?» lo incalzò Philippos.
Alford si voltò, lo guardò negli occhi e fece una smorfia:
«Be’, ormai ci ho scommesso le palle, giusto?»
Il vecchio fece un ampio sorriso fiero e soddisfatto e gli diede una pacca sulla spalla:
«Hai fatto la scelta giusta, Alford»
L’Ammazzatitani ricambiò il sorriso e si strofinò le mani, quando si ricordò cos’era successo prima della visita a sorpresa del Sapiens:
«Ehi, Phil, i pescatori di Honolulu mi hanno organizzato una piccola festa, visto che non ho preteso niente per scacciare il Tiamat. Vuoi venire anche tu, per caso?»
Philippos ridacchiò e annuì con vigore:
«Certo che sì! Sono ancora stremato per il lungo viaggio per mare, un po’ di allegra compagnia esotica sarebbe l’ideale»
«Ottimo, così puoi attirare tutta l’attenzione per me»
«Non ti allargare»
Quindi i due uscirono dal bungalow, andarono al bagnasciuga e spinsero la barca di Alford in mare, dopodiché l’Ammazzatitani richiamò Godzilla con la conchiglia.
Notes:
30/03/2024 - A quanto pare, Adam Wingard ha avuto la stessa idea che è venuta a me due anni fa e ha fatto scontrare Godzilla e Tiamat in mare. Se solo quella scena da Godzilla e Kong fosse stata un vero scontro... in tutta onestà, il film in generale mi ha deluso. Difatti, è la prima volta che mi va male con un film del Monsterverse. Se non altro, posso ancora divertirmi con questa storia, sperando che intrattenga anche voi.
Chapter 3: Alle Azzorre
Chapter by Roberto_Turati
Chapter Text
La barca a vela solcava l’oceano a grande velocità, trainata da Godzilla. Il cielo era nuvoloso, l’aria era fredda e umida e le onde erano alte. Alford e Philippos stringevano la presa alla barca, avvolti in spessi mantelli per ripararsi dal freddo e dagli spruzzi d’acqua. Il marinaio prevedeva pioggia nei giorni a venire, nel qual caso gli sarebbe toccato ordinare a Godzilla di aggirare la tempesta. Alford faceva di tutto per mostrarsi occupato a governare la barca e tenere d’occhio il cielo, nella speranza che Philippos non approfittasse del silenzio e della calma per iniziare discussioni scomode. Alla fine, però, non ci fu più modo di rimandare l’inevitabile:
«Se permetti, reputo che avresti un aspetto molto più decoroso se ti fossi rasato del tutto e avessi accorciato i capelli il doppio. Prima sembravi un selvaggio, ora pari un selvaggio civilizzato»
Alford alzò gli occhi al cielo e ribatté:
«Senti, è già tanto che ti abbia dato un contentino, quindi fattelo bastare»
Come per istinto, si accarezzò la barba. Era passato così tanto tempo che ora gli dava una strana sensazione poter sentire la pelle delle sue guance sotto le dita. Se non altro, la barba corta si incrostava molto meno di salsedine. Philippos si era già lamentato più volte perché Alford aveva rifiutato di fare il bagno prima di partire, ma lo riteneva inutile: avrebbero traversato due oceani interi e circumnavigato l’Africa, quindi lavarsi non aveva senso. Semmai, si sarebbe concesso un risciacquo una volta arrivati alle Azzorre. Philippos non era convinto:
«Per quanto mi rincresca constatarlo, molti dei miei soci Sapientes giudicano le persone dalle apparenze ed è alquanto difficile far cambiare loro idea. Curare il tuo aspetto ti avrebbe dato un piccolo aiuto nel dare prova del tuo miglioramento come essere umano»
«I tuoi amici sapientoni possono pensare quello che vogliono. Lasceremo parlare i fatti»
«Così sia. Mi auguro che i fatti siano persuasivi anche per i nostri sodali Padroni di Titani»
Alford non disse più nulla. In quel momento, Godzilla tagliò in due un’onda gigante passandoci attraverso e i due uomini si chinarono per ripararsi dallo schizzo. Fu come una doccia fredda in una notte invernale e Alford trattenne un’imprecazione a denti stretti, scosso dai brividi. Philippos, dal canto suo, brontolò qualcosa in greco e il marinaio dedusse dal tono cosa poteva significare.
«Ecco un altro motivo per cui mi sono ritirato ai tropici» scherzò Alford.
Philippos si asciugò la faccia con un lembo del suo mantello e sorrise:
«A proposito di tropici, mi hai sorpreso alla piccola celebrazione isolana in tuo onore, la sera prima della nostra partenza. Certo, il fatto che ti trovassi fuori dal tuo elemento era evidente al punto che i locali non sapevano proprio cosa fare con te, ma perlomeno hai partecipato»
Alford fece una risatina spontanea:
«Ma che dici? Non ero fuori dal mio elemento, è stato quel Kilani a mettermi in imbarazzo con le sue battute»
«Presumo che fosse il giovane col pappagallo e un disperato bisogno di farsi notare dal gentil sesso»
«Sì»
«Se davvero la colpa è da imputare a lui, ti tranquillizzo subito: non sarà presente nessuno con una personalità simile, all’incontro. Insomma, forse uno dei Padroni di Titani, tuttavia ti garantisco che sa comprendere quando la situazione richiede la serietà»
«Ehi, guarda laggiù: terra»
Alford indicò l’orizzonte: dove l’occhio si perdeva, era apparsa la sconfinata linea della costa africana. Sopra la riva, la coltre di nubi si apriva e suggestive lame di luce illuminavano la spiaggia. Il contrasto con l’oceano soprastato da cumulonembi sembrava surreale. Philippos allungò il collo per osservare la costa e rifletté:
«Molto bene, inizia la parte più facile del viaggio. Non dovremo fare altro che seguire la costa fino all’Atlantico e dirigerci a nord, fino alle isole dove si terrà la riunione»
«E se attraversassimo il continente?» propose Alford.
«Perché mai scomodare il tuo titano? È una creatura anfibia, lasciala nel suo vero territorio»
«Se è per quello, avremmo fatto molto prima passando dalla Terra Cava»
A quelle parole, Philippos lo fissò con severità e lo apostrofò:
«No, ragazzo mio, sei ben consapevole della mia posizione al riguardo»
«Come ti pare. Siamo ancora in tempo a prendere l’ingresso più vicino, se cambi idea»
«Non succederà. La dimora dei titani è un luogo a cui non apparteniamo, non possiamo certo farne una banale scorciatoia per un viaggio poco convenzionale. Non dimenticarlo mai: se vi discendiamo, significa che il motivo è fondamentale»
La predica di Philippos andò avanti ancora per molto, ma Alford smise di ascoltarlo molto presto: preferiva di gran lunga badare alla navigazione.


Dopo settimane di navigazione, giunsero infine in vista dell’arcipelago delle Azzorre. Alford seguì le istruzioni di Philippos e indirizzò Godzilla verso la costa di Pico, l’isola dell’omonimo vulcano. L’Ammazzatitani avrebbe dovuto aspettarsi che i Sapientes avessero la loro sede lì: molti vulcani erano ingressi per la Terra Cava e, se c’era un passaggio per il regno dei titani, gli eruditi ossessionati da quel mondo nascosto non erano mai lontani. I marinai navigarono fino al porto del villaggio di Lajes. Una volta che furono abbastanza vicini, Alford suonò la conchiglia e Godzilla si fermò. Il titano tirò la testa fuori dall’acqua e si voltò verso il padrone, in attesa di nuovi ordini. Alford avvicinò la barca alla creatura e sciolse la corda legata alla cresta, dopodiché fece i gesti per comandargli di trovare una spiaggia. Godzilla soffiò con le narici e scomparve sott’acqua.
«I tuoi colleghi cervelloni saranno già tutti qui?» chiese Alford a Philippos.
«La probabilità che noi due siamo tra gli ultimi, se non gli ultimi a giungere su questa ridente isola, è assai alta»
«Siamo in ritardo?»
«Oh, suvvia, ragazzo! Pensavi davvero che l’associazione fosse stata così ingenua da fissare una data, quando il viaggio è lungo e scomodo per tutti i suoi membri? L’assemblea inizierà soltanto quando l’ultimo Sapiens tra quelli convocati avrà annunciato la sua presenza»
«Allora, se siamo gli ultimi, sappiamo che ci hai fatto fare brutta figura per aver voluto scegliere la strada lunga»
Dopo una risata sarcastica, Alford iniziò le manovre di attracco. Trovarono un posto libero al molo, legarono la barca e ammainarono la vela. A quel punto, scaricarono i loro bagagli e misero piede sulla terraferma per la prima volta da pressoché un mese di traversata oceanica. Philippos rifilò subito i suoi fagotti ad Alford e si mise in marcia con le mani dietro la schiena, mentre il marinaio lo seguiva a passo goffo, con due sacchi sottobraccio e uno a tracolla.
«Vuoi aiutarmi a reintegrarmi o avevi solo bisogno di un garzone?» si lamentò Alford.
Philippos si voltò e gli rivolse un ghigno sardonico:
«Non mi permetterei mai di commettere una tale bassezza. Ti affido i carichi di entrambi per il semplice motivo che sei assai più giovane ed energico del sottoscritto. Peraltro, in questo modo ti offro un metodo per fare un poco di esercizio fisico e iniziare a tornare alla forma smagliante con cui ti ricordavo»
«Grazie di avermi ricordato che mi sono lasciato andare»
Mentre si punzecchiavano e attraversavano il villaggio, gli abitanti di Lajes osservavano affascinati la cresta di Godzilla che solcava il mare lungo la costa. Alford trovò affascinante la loro reazione: capiva dai loro sguardi che lo riconoscevano, eppure gli sembrava che per loro fosse tutto normale. Si capiva che erano abituati alla visita dei Padroni di Titani, complice il fatto che l’isola era una sede dei Sapientes. Alford si sentì confortato: essere guardato in quel modo era una novità ben accetta, abituato com’era a essere temuto. Sperava che Phil avesse ragione e che un giorno diventasse così dappertutto.
«Dove stiamo andando?» chiese.
«Il punto di incontro dell’associazione è un’antica fortezza a strapiombo sul mare. Secoli orsono, la generazione dei Sapientes pionieri della Terra Cava si stabilì in questa roccaforte per generosa concessione di Filippo II, re di Spagna. Da allora, viene tenuta in condizioni ottimali e impiegata…»
«Hai risposto alla domanda, ora basta» lo interruppe Alford, seccato.
L’Ammazzatitani seguì il vecchio greco fuori dal villaggio portuale, lungo un sentiero di pietra sul lungo mare. Poco dopo, raggiunsero una spiaggia in una baia. Dall’altra parte dell’insenatura, una scala di pietra risaliva la parete rocciosa degli scogli e conduceva a una piccola fortezza a strapiombo sul mare. Da lì, potevano vedere le mura coi merletti, due torri di guardia e le aste con le bandiere agitate dal vento. Il posto era incantevole: era quasi il tramonto e la luce dorata creava una rilassante atmosfera nella baia.
«Il posto è delizioso» commentò Alford.
«Sono lieto che sia di tuo gradimento. Se mi concedi un momento di sincerità, era tra le mie preoccupazioni»
«Figurati, ho provato a dormire su uno scoglio di pietra alle Shetland: questo è un lusso, per me»
Iniziarono ad attraversare la spiaggia; Godzilla emerse dal mare in quel momento. Immerso fino alle ginocchia, accolse il padrone con un gorgoglio, per poi uscire del tutto dall’acqua e sdraiarsi a ridosso degli scogli. Alford notò delle guardie appostate sulle mura. Quando videro lui e Philippos arrivare, si scambiarono qualche parola e una di esse andò via di corsa. Salirono la scalinata e raggiunsero una terrazza circondata da un muretto.
«Ebbene, siamo arrivati» annunciò Philippos.
Poco dopo, il portone della fortezza si aprì e la guardia che se n’era andata tornò, accompagnata da un gruppo di servi dal portamento ben educato e dagli abiti raffinati. Accolsero i due ospiti con un lieve inchino e invitarono Philippos a farsi accompagnare nei suoi alloggi. Il vecchio esortò Alford:
«Molto bene, Alford, ora non devi fare altro che lasciare che la servitù si occupi di tutto. Non sei entusiasta di giacere di nuovo su un vero e proprio letto?»
Alford era rimasto interdetto, incapace di reagire a tutta quella sottomissione riverente. Tre dei domestici gli si avvicinarono e gli chiesero in tono cordiale di lasciare i bagagli a loro. Gli ci volle un attimo per elaborare tutto, ma si riscosse e scaricò i fagotti nelle loro mani senza tante cerimonie, facendoli barcollare un po’ per il modo improvviso con cui aveva rifilato loro il peso. Quando i servi furono entrati coi suoi fagotti, Alford si avvicinò al parapetto della terrazza d’ingresso e vi si appoggiò, intento a godersi il panorama. Si mise a guardare gli aloni vermigli creati dal sole che tramontava dietro l’oceano: faceva di tutto per rilassarsi, per scordare l’apprensione dovuta all’imminente incontro coi tre Padroni di Titani.
Dopo un po’, vide uno spruzzo bianco al largo: c’era una balena che usciva in superficie per respirare. Come si aspettava, subito dopo sentì un rumoroso ringhio provenire dalla spiaggia: Godzilla aveva sentito la balena e si era svegliato. Doveva avere fame. Sia Alford sia le guardie osservarono il titano che strisciava fino al mare e spariva sott’acqua per andare a caccia, lui con indifferenza e loro con soggezione. All’improvviso, sentì una tonante voce bonaria dietro di sé:
«Ma dai! È proprio lui! L’uomo, la leggenda!»
Alford si voltò e sbarrò gli occhi, basito. Era apparso un omone grasso dai lunghi capelli biondi e i baffi folti, col naso e le guance paonazze e una flaccida pancia che sporgeva da sotto i suoi vestiti. Barcollava, ridacchiava e sorseggiava di continuo da un boccale di birra; Alford riconobbe l’alcolico dall’alito del nuovo arrivato, che si sentiva a distanza di metri. O forse era il suo sudore? I suoi abiti avevano due macchie enormi sotto le ascelle. Il grassone salutò le guardie con dei cenni, per poi guardare Alford e allargare le braccia:
«L’Ammazzatitani! Alla fine hai trovato anche me, ahahahaha! Sei qui per farmi perdere tutto?»
“Partiamo benissimo” pensò Alford.
Dall’oceano provenne un getto di spuma gigantesco. Tutti i presenti si voltarono giusto in tempo per vedere Godzilla che saltava fuori dall’acqua con la balena in bocca: la stava trascinando per la coda. Quando ricadde in acqua, sollevò uno spruzzo ancora più immenso. L’ubriacone applaudì e rovesciò birra dappertutto:
«Caspita, che spettacolo! Hai fatto così anche al massacro di Bilbao?»
«Quale massacro? A Bilbao diedi solo una prova di potenza» si difese Alford.
«Ah, sì? Chiedilo ai parenti delle vittime»
Il marinaio non rispose. Le guardie li stavano fissando con espressioni coinvolte, il che non faceva che rendere tutto ancora peggiore. Fu il grassone a passare oltre, con una poderosa pacca sulla schiena:
«Be’, che ci facciamo ancora qui? Vieni dentro! Ti devo presentare agli altri!»
«Sono già tutti qui?»
«Ma certo! Vi aspettavamo da una settimana! Sicuro che il tuo titano sia un lucertolone e non un tartarugone? Da lontano si fa fatica a distinguerli»
Alford decise di non commentare: non gli voleva dare la soddisfazione di riuscire a innervosirlo. Senza cessare un attimo di ridere a crepapelle, l’omone lo accompagnò nel castello. Mentre attraversavano corridoi di pietra decorati con dipinti di titani e reperti come zanne e artigli, Alford si ricordò di non essersi ancora presentato davvero:
«So che lo sai già, ma in ogni caso, mi chiamo Alford. E tu?»
«Per te e chiunque altro, sono Boyd. Ti direi che è un piacere conoscerti, ma così la dama smorfiosa si indigna»
«Chi?»

Boyd portò Alford al piano sotterraneo della fortezza, in una cantina dei vini. Era un modesto seminterrato di pietra in cui l’aria era fresca e piacevole: l’ideale, dopo aver sopportato il sole che picchiava tutto il giorno, in mezzo al mare. Da un lato, c’era la parete con le botti di vino; dall’altro, erano ammassati dei barilotti di birra e Boyd affermò con orgoglio di averli portati tutti lui per l’occasione. Questo fece sospettare ad Alford che i casi fossero due: o i Padroni di Titani meditavano fin dall’inizio di ubriacarsi per inveire il doppio contro di lui, o il biondo era fuori di testa. Si stupì di sperare che l’ipotesi giusta fosse quest’ultima.
«Eccoci!» esclamò Boyd.
In un angolo della cantina, era stato apparecchiato un tavolo con calici di vino che accompagnavano piatti di pesci essiccati e frutti di mare. Al tavolo erano sedute due persone: un uomo in abiti borghesi coi capelli rossi e spettinati, coperto di tatuaggi sulle braccia e sul collo, e una bella donna con capelli castano chiaro raccolti in un complesso chignon, che sfoggiava un raffinato abito di seta. Alford sapeva che era un indumento asiatico, ma lei non lo era. Anzi, tutti e tre i Padroni di Titani erano europei. Quando sentirono Boyd, smisero di parlarsi e fissarono l’ospite in silenzio. Dopo una breve esitazione, Alford osò rivolgere loro la parola:
«Come vi chiamate?»
La donna fece un’espressione sdegnosa:
«Di solito ci si presenta, prima. Per buona educazione»
«Ma sapete già chi sono»
«Sei proprio superbo come ti immaginavo»
Il rosso fece spallucce:
«Eh, però non ha torto. Comunque, mi chiamo Emory»
«Sybil» aggiunse lei.
Boyd andò a riempire di nuovo il suo boccale da uno dei barilotti e borbottò:
«Oh-oh, ha già quel tono»
La donna sbuffò e gli rivolse un’occhiata offesa. Emory tossì per metterli entrambi in riga, dopodiché si alzò, andò a prendere una sedia da un angolo e la sistemò tra la sua e quella di Sybil, quindi invitò Alford a sedersi con un cenno.
«Grazie» disse l’ospite.
Dopo che si fu accomodato, anche Boyd si stravaccò in modo sgraziato su uno sgabello a tre gambe e iniziò a ingozzarsi di frutti di mare senza ritegno. Alford ignorò le occhiatacce ostili di Sybil e prese un pezzo di pesce spada dal centro del tavolo. Mentre lo assaporava, Emory congiunse le mani e gli chiese:
«Dunque, ora il famigerato Ammazzatitani ammazza titani a fin di bene?»
Alford annuì:
«Sì. Io e Godzilla giriamo per il mondo e aiutiamo la gente quando i titani selvatici la minacciano. Oppure stiamo alle Hawaii, dove non diamo fastidio a nessuno»
«Oh, ma quanta premura!» commentò Sybil, sarcastica.
Ad Alford non piacque per nulla quella provocazione, ma si sforzò di nascondere l’irritazione. Non doveva fare una brutta impressione, costasse quel che costasse. Emory raddrizzò la schiena e domandò:
«Ne hai ammazzato qualcuno di recente?»
«Non proprio. Ho scacciato un Tiamat dalle Hawaii, prima di venire qui. Aveva delle uova e ho capito che gli sarebbe bastato fuggire da Godzilla, così l’ho lasciato vivere»
Sybil lo schernì:
«Sarebbe stato molto più gradevole da parte tua ragionare così anche con le persone, ma stendiamoci un velo pietoso»
«Ohohoho, è sul piede di guerra!» rise Boyd.
«Capisco» mormorò Emory.
Alford finì il pesce spada e sgusciò alcune vongole. Tutti gli sguardi erano puntati su di lui e, a parte Boyd, era l’unico che stava mangiando. Gli pareva la distrazione migliore dalla tensione nell’aria. Volle provare a rompere il ghiaccio:
«La mia reputazione mi precede, ma non ho mai sentito parlare di voi. Quali sono i vostri titani? Dove vivete? Siete protetti da qualche regno?»
Boyd rimase a bocca aperta:
«Oh! Guardate: ci tiene! Che bello! Inizio io: ho un Anguirus. Per me è sempre stato come un fratello maggiore scemo, ma gigante e a quattro zampe»
Sybil alzò un sopracciglio:
«Vorrai dire un cagnolone scemo»
«Eh? Uhm… no? Intendo proprio un fratello maggiore scemo. C’era già quando sono nato»
«Boyd, tutti i nostri titani c’erano già quando siamo nati»
«E allora? Comunque, io e Pigau stiamo in Africa. Gli Etiopi ci pagano bene per fornire materiali per costruire le città; o per far sprofondare quelle di chi sta antipatico a loro. Almeno credo, era solo un’idea dell'imperatore Bakaffa»
Alford si rivolse a Emory:
«Tu, invece?»
Il rosso fece un sorriso fiero:
«Il titano della mia famiglia è Barcud, il Rodan più veloce e maestoso delle Ande!»
«Quindi vivi da qualche parte in Sudamerica?»
«Solo in teoria. Nella pratica, non sto mai fermo in un posto. Io e Barcud abbiamo visitato e mappato più terre sconosciute di qualunque pioniere negli ultimi secoli»
«Aspetta, sei l’esploratore volante di cui parlavano tutti? Quello che è stato ai due poli e atterrato sull’Everest?»
«In persona! Che te ne pare?»
«Penso che dovresti esserne orgoglioso»
Emory scoppiò a ridere:
«Scherzi? Certo che lo sono! Guarda qui»
Il rosso iniziò ad arrotolarsi le maniche, sollevarsi i pantaloni e le vesti e tirarsi giù il colletto. Alford osservò i suoi tatuaggi e vide che erano tutte raffigurazioni stilizzate dei posti più disparati. Con un sorriso compiaciuto, Emory spiegò:
«Belli, vero? Me ne faccio fare uno per ogni meta che raggiungo, come i due poli ghiacciati, per l’appunto. Sto tenendo da parte la schiena per quando avrò raggiunto il mio traguardo più ambito»
«Vale a dire?»
«L’abisso più oscuro della Terra Cava! I Sapientes scolpiranno miei busti per il resto della storia e li metteranno accanto a quelli del Romano che li ha fondati, come minimo»
Boyd ridacchiò sotto i baffi:
«Ti adoro, Emory: sei sempre così sognante! Dev’essere una cosa da vagabondi»
Alford, allora, fece un sospiro nervoso e guardò negli occhi Sybil, che gli lanciò subito un’occhiata di sfida. Gli sembrava chiaro che stava preparando la prossima frecciatina. Le fece la domanda:
«E tu? Bei vestiti. Mi ricordano quelle vestaglie che indossano in Giappone»
«Kimono» precisò lei.
«Sì, ecco. Ti piace l’Oriente? So che va di moda»
Ma la donna alzò la mano, con un ghigno malizioso:
«Oh, non c’è fretta, Ammazzatitani. Stavamo parlando dei tatuaggi di Emory, mi sembra un peccato non fare menzione della persona che glieli fa. Tu che dici, Emory? Non vogliamo fargli sapere perché ha una grande faccia tosta a sedersi a tavola con te e parlarti come se niente fosse?»
Emory si serrò le labbra chinò lo sguardo. Alford iniziò a preoccuparsi e, con fare cauto, gli chiese:
«Di che sta parlando? Ti ho fatto un torto di cui non so niente?»
Il rosso girò il capo dall’altra parte, mentre Sybil faceva un sorrisetto maligno. Boyd rimase a guardare con una faccia inebetita, per poi alzarsi e borbottare:
«Vado a prendere altra birra»
«Scusate, posso sapere a cosa alludete? Voglio capire» insisté Alford.
Alla fine, Emory sospirò e rivelò tutto:
«Il mio tatuatore è un carissimo amico, un compagno Padrone di Titani. Si chiama Jaime e si occupa di spianare sentieri in Amazzonia con un Behemoth. Ti sembra familiare?»
«Un modo davvero pacchiano di collezionare zanne d’elefante» scherzò Sybil, sarcastica.
In un baleno, Alford unì i puntini e fu travolto da un’ondata di vergogna e panico: sapeva benissimo di cosa si parlava. Anni prima, in una “spedizione” in Sudamerica, lui e Godzilla avevano sfidato un Padrone di Titani con un Behemoth nella giungla amazzonica. Lo scontro fra Godzilla e l’altro titano era stato breve, ma caotico. Alla fine del combattimento, l’avversario aveva perso una zanna. Alford non si era mai preso la briga di apprendere il nome di quel Padrone di Titani; fino a quel momento.
«Cazzo» mormorò.
«Eh, già. Come la mettiamo?» lo incalzò Sybil.
«Eccola che soffia sul fuoco. Sarà uno spasso» borbottò Boyd.
L’Ammazzatitani guardava ora la donna, ora Emory, in cerca delle parole giuste. Alla fine, optò per delle scuse sincere:
«Mi dispiace tanto. Se non altro, non uccisi nessuno dei due»
Emory si grattò il collo, contrariato:
«Insomma, non dico che non mi fa piacere, ma questo non significa che la vita di Jaime è stata rose e fiori, da quel giorno. Ha perso credibilità, sia tra la gente sia tra gli altri Padroni di Titani. Soltanto l’anno scorso, i governi dell’America spagnola gli hanno chiesto di tornare a creare sentieri nella giungla, ma solo per disperazione»
Boyd tracannò il suo intero boccale, ruttò senza riguardo e raccontò fra i singhiozzi:
«Quel povero diavolo era più depresso di un… di un… qualunque cosa sia depresso, insomma. Per fortuna, c’eravamo noi: gli abbiamo dato man forte»
Sybil scacciò l’odore del suo alito con la mano e puntualizzò:
«Ehi, siamo concreti: gli ho dato io man forte, con le mie finanze. Voi gli avete solo dato pacche sulla spalla»
«Donna! Le pacche sulla spalla tra uomini sono magiche! Guarda»
Alzò un braccio con fare flaccido e provò a schiaffare la mano sulla schiena di Emory. Tuttavia perse l’equilibrio, mancò l’amico e si rovesciò sul pavimento assieme al suo sgabello. Iniziò a piagnucolare che aveva sbattuto il naso. Alford si asciugò i sudori freddi dalla fronte e dal collo e fece un tentativo di riprendere il discorso delle presentazioni:
«Finanze? Quindi sei una donna ricca?»
Sybil si inorgoglì, si alzò e girò su se stessa con grazia, come se danzasse. Mise bene in mostra il suo kimono, che era giallo canarino e decorato con intricatissimi ricami di filo d’oro. Gli rivolse un sorriso sprezzante:
«Dire che sono ricca, Ammazzatitani, è un eufemismo. Il patrimonio della mia famiglia farebbe invidia al papa»
«Cosa fai di mestiere?»
«Sono cresciuta in Cina: la mia famiglia è nell’industria della seta da generazioni. La mia bellissima Glöyn tesse i fili più robusti d’Oriente da quando era una larva!»
Alford capì:
«Una Mothra»
«Esatto, oppure Mosura, per gli esotisti che comprano le mie sete. Adorano le pronunce locali. Tuttavia, per qualche motivo, non sento più nessuno dire Gojira. È come se avessero paura di qualcosa o qualcuno. Non ne sai niente?»
Boyd, ancora accasciato sul pavimento, alzò il braccio da terra ed esclamò:
«Lo so io!»
Alford fu colto da un’improvvisa ondata di rabbia e scattò in piedi, quasi d’istinto. Si parò davanti a Sybil, che era una donnina minuta, e la fissò negli occhi dall’alto:
«Smettila. Basta ricordarmi che mi detestate. Lo so già»
Sybil si alzò in punta di piedi per avvicinarsi il più possibile al suo volto e ribatté:
«Forse hai ragione: dovrei ricordarlo a Philippos, visto che si è illuso che invitarti qui fosse una buona idea»
Alford chiuse gli occhi e fece dei frenetici respiri nervosi: doveva trattenersi. Indietreggiò e strinse i pugni così forte da farsi tremare le braccia. Emory tirò indietro la sua sedia, con uno sguardo preoccupato:
«D’accordo, cerchiamo di restare pacati e civili! Sybil, per favore, non istigarlo più. È venuto in pace, dovremmo concedergli una possibilità»
Sybil si voltò verso di lui, sconcertata:
«Scusami, ma tu da che parte stai? Ora provi empatia per questo mostro?»
Boyd si mise seduto con un rantolo e rise:
«Ah, è lui il mostro? Pensavo che fossi tu ogni…»
«Zitto!» lo interruppe lei.
Emory si coprì la faccia per nascondere un sospiro carico di tensione. Alzò le mani e fece una proposta:
«Perché non chiediamo la conferma definitiva? L’ultima parola sta a te, Ammazzatitani: sei qui in pace? Ci si può fidare di Philippos, quando dice che vuoi cambiare?»
Fino a poco prima, Alford avrebbe apprezzato la disponibilità del rosso. Ma ormai era troppo tardi: dentro di lui ardeva un fuoco rovente, attizzato dalla sfrontatezza di quella sobillatrice. Ci aveva provato, ma quei tre non avevano fatto altro che premere i suoi tasti dolenti per tutto il tempo. Talvolta per sbaglio, spesso di proposito, ma non gli importava: ora voleva solo mandarli tutti al diavolo. Quindi si appoggiò al tavolo, ne strinse i bordi fino a farsi sbiancare le nocche e ribatté:
«Certo che avete la faccia come il culo»
Emory sobbalzò, a occhi sbarrati. Socchiuse la bocca, ma non riuscì a parlare. Alford non si trattenne più e vomitò tutta l’ira che gli ribolliva dentro:
«Sono venuto qui con tutte le migliori intenzioni. Ci credevo davvero! Philippos mi ha convinto sul serio che ci fosse un’occasione di riscattarmi con questo incontro! Ma voi tre siete come tutti i Padroni di Titani con cui ho avuto a che fare»
«Ovvero?» chiese Sybil.
Alford si staccò dal tavolo e spinse via una sedia tra loro due con un calcio. La donna ebbe un sussulto e fece un passo indietro, colta alla sprovvista. L’Ammazzatitani le puntò il dito contro e sbraitò:
«Avete una baldanza più grossa dei vostri titani! Ho perso il conto di quanti ne ho affrontati, ma non facevano mai eccezione: mi prendevano per il culo, mi trattavano come se potessero prendermi a pesci in faccia come un cazzo di schiavetto! Be’, sapete cos’altro avevano in comune? Hanno smesso di dare aria alla bocca, dopo che li ho schiacciati come formiche! Erano dei palloni gonfiati e ho goduto nell’uccidere i loro titani»
«Dunque lo ammetti» ghignò lei, soddisfatta.
«Non c’è niente da ammettere! Dico solo quello che vedo! Siete dei frustrati, dei disadattati che vanno in giro a fare i pavoni coi loro titani perché non hanno un posto nella società e fanno comunella con altri stronzi uguali per sentirsi capiti! E dovrei farmi perdonare da voi?!»
Boyd si mise seduto con un rantolo e reclinò il capo, perplesso:
«Eh? Che cazzo dici?»
«Vi descrivo! Non è ovvio?»
Emory fece spallucce:
«A dire il vero, nessuna delle cose che hai detto è vera, almeno per noi tre. A parte che è stato molto scortese da parte tua fare di tutta l’erba un fascio in questo modo»
Sybil incrociò le braccia:
«Disadattati! E secondo te da dove viene il mio florido commercio di seta, se non so stare al mondo come dici tu?»
Boyd fece un’espressione maliziosa e puntò un indice accusatore:
«Eppure conosci qualcuno che è così, vero? Si capiva che sapevi di che parlavi»
Alford rifletté meglio sulle sue parole e si rese conto di tutte le falsità che aveva appena sbraitato. Sbarrò gli occhi e indietreggiò:
«Io… ehm… stavo…»
Emory lo incalzò:
«Vuoi spiegarti o no? Questa è la tua occasione. Ti ascoltiamo, se hai una giustificazione che tiene»
«Ma questa volta non c’è Philippos a salvarti con la sua parlantina» minacciò Sybil.
All’improvviso, una morsa gelida strinse lo stomaco di Alford ed estinse in un attimo il suo rogo interiore. Non aveva soppesato le parole; ora era stato messo all’angolo.
«Ehilà? Ti sei incantato?» chiese Boyd.
Alford non disse nulla. Si voltò di scatto e sfrecciò fuori dalla cantina, su per le scale. Non si fermò, ma sentì i tre Padroni di Titani che si scambiavano commenti. Non aveva nessuna intenzione di fermarsi a scoprire cosa si stavano dicendo. Voleva solo scappare il più lontano possibile da loro. Corse come una lepre lungo i corridoi di pietra della fortezza; sceglieva le direzioni a caso quando trovava un bivio e cercava l’uscita. All’improvviso, dopo aver svoltato un angolo, andò a sbattere contro una persona. All’impatto, Alford perse l’equilibrio e sentì un vuoto nello stomaco, mentre finiva sottosopra. Ruzzolò sul pavimento e si ritrovò sdraiato sul tappeto in mezzo al corridoio, con le ginocchia e le spalle doloranti. La persona che aveva investito sbraitò:
«Insomma, che razza di maniere! Ti sembra questo il… Alford?»
L’Ammazzatitani impallidì: era Philippos! Si rialzò in piedi in tutta fretta e fece dei passi indietro, pronto a darsi alla fuga. Ma il Sapiens si alzò a sua volta e gli si avvicinò subito, preoccupato:
«Non ti ho mai visto così turbato, ragazzo mio! A malapena ti riconosco! Cosa accade? Cosa può averti scosso così tanto?»
Alford si afferrò un braccio e strinse la presa fino a farsi sbiancare la pelle. Guardò fuori dalla finestra più vicina, con le labbra tremanti. Philippos gli poggiò una mano sulla spalla e lo guardò negli occhi, con fare apprensivo:
«Riguarda il tuo incontro coi Padroni di Titani? Avete affrontato argomenti troppo delicati o scottanti? Coraggio, parlami! Aiutami a comprendere il tuo stato d’animo!»
Il marinaio si voltò, in preda alle palpitazioni, e mormorò con un filo di voce:
«Ho commesso uno sbaglio, Phil. Non sarei dovuto venire qui. La tua idea era pessima fin dall’inizio»
«Sono sicuro che siete solo partiti col piede sbagliato. Forse, con un approccio più…»
«No!»
Quello scatto d’ira fu così repentino che Philippos si lasciò sfuggire un grido spaventato e sobbalzò all’indietro, con un’espressione stravolta. Alford lo fissò furioso per minuti, madido di sudore e rigido come un tronco. Quando si calmò, si passò le mani sui capelli e si coprì il volto, distrutto. Philippos iniziò a camminare avanti e indietro, con le mani dietro la schiena. Alla fine, sospirò:
«Capisco. Forse ho sottovalutato l’entità del pregiudizio umano»
«Lascia stare. Ho chiuso. Ti accompagnerò dovunque debba andare quando avrai finito qui, ma giuro che poi non voglio mai più incontrare un Padrone di Titani in vita mia»
Philippos annuì:
«Rispetterò questa scelta. Mi dispiace che sia andata così. Volevo solo darti una possibilità di migliorare la tua vita. Forse eri già soddisfatto sulla tua isola»
«Caspita, che genio! Te l’ho giusto detto chiaro e tondo» infierì Alford.
«Ascolta, è ovvio che non sei lucido, in questo momento. Ti serve una distrazione. Propongo che tu assista al primo colloquio per ponderare la scelta del nuovo Magister Sapientium»
«Che mi importa di una cerchia di sapientoni che giocano ai politici?»
«Nulla, com’è giusto che sia. Tuttavia, non si parlerà solo dell’organizzazione interna: saranno toccati anche temi che potrebbero stimolare il tuo interesse, quali i nostri progetti in cooperazione coi Padroni di Titani e le nuove direttive sulle ricerche nella Terra Cava»
«Uhm…»
In quel momento, da lontano, si sentirono i rintocchi di una piccola campana. Philippos si strofinò le mani con un sorriso:
«Ah, giusto in tempo! L’ultimo Sapiens ha raggiunto l’isola ed è pronto per il dibattito. Andiamo?»
«D’accordo»
Dopo una serie di sospiri, l’Ammazzatitani seguì il vecchio greco lungo i corridoi, mentre le guardie passavano per accendere le torce interne: ormai era sera e dalle finestre entrava solo la pallida luce della luna.
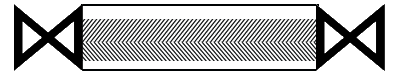
Alford seguì Philippos fino al salone principale della fortezza. Al centro della stanza, c’era un lunghissimo tavolo per banchetti pieno di risme di documenti e quaderni dalle copertine di cuoio. Il locale era illuminato da file di torce a muro, oltre che dalla luce del cielo notturno che entrava dalle finestre. Quando arrivarono loro due, i Sapientes si stavano mettendo a sedere e si parlavano sottovoce. Alford diede un’occhiata rapida ai presenti: erano tutti di mezza o terza età e appartenevano alle etnie più disparate. Europei, africani, asiatici e altri ancora. C’era una varietà di colori della pelle e di stili di abbigliamento che si era abituato a vedere solo a Honolulu.
«Ti procurerò uno sgabello per assistere all’assemblea da una posizione discreta» gli disse Philippos.
Il vecchio si allontanò e si perse tra la folla. Alford attese in piedi per qualche minuto e, in breve tempo, i vari eruditi lì presenti iniziarono ad accorgersi di lui e fermarsi per fissarlo con sguardi sospettosi o preoccupati, a seconda della persona. Quando Philippos tornò con uno sgabello a tre gambe, Alford glielo sfilò di mano con fare brusco e andò a rintanarsi in un angolo.
«Vedrai che riusciremo a intrattenerti, a modo nostro» gli promise Philippos.
Ci vollero alcuni minuti, perché calasse il silenzio. Adesso tutti i membri dell’associazione che studiava i titani e qualunque cosa vi ruotasse intorno erano riuniti e pronti al colloquio. Ciascuno aveva la sua risma di fogli da sfogliare e consultare. Un Sapiens coi baffi e una toga bianca entrò nella stanza, con un busto di marmo tra le braccia. Lo adagiò al centro del tavolo, si spostò a capotavola e, dopo essersi schiarito la voce, diede inizio al discorso di apertura:
«Distinti ed esimi compagni Sapientes, tramite fra la conoscenza umana e il selvaggio e alieno mondo dei titani dal sottosuolo! Stasera, nella nostra sede alle Azzorre, sotto lo sguardo del nostro venerato fondatore Plinio il Vecchio, dichiariamo aperto il dibattito per scegliere il successore del nostro compianto Magister Sapientium, che ci ha lasciati tre mesi orsono»
I Sapientes chinarono il capo rivolti al busto, quindi l’uomo a capotavola prese la sua pila di documenti e iniziò a leggere:
«Prima di valutare i membri ritenuti idonei al ruolo, passeremo in rassegna le ricerche e le operazioni che sono rimaste sospese in corso d’opera a causa della dipartita improvvisa del Magister Sapientium. Punto primo: le esplorazioni delle regioni ritenute edificabili della Terra Cava, alla ricerca di possibili rovine di insedimenti minori degli Aleutiani. Punto secondo: il restauro e l’osservazione dei relitti di dispositivi e apparecchi meccanici con alimentazione a titanite. Punto terzo: la ricopiatura dei bassorilievi rinvenuti sugli edifici delle rovine di Diatidi, che rimarrà la nostra base di ricerca principale nella Terra Cava. Punto quarto: le trattative coi regnanti delle grandi nazioni per richiedere sostegno economico per le nostre ricerche sul campo, nonché un'eventuale difesa militare che protegga i membri delle nostre spedizioni sul campo dalla fauna della Terra Cava. Punto quinto: idee per futuri progetti di collaborazione coi Padroni di Titani affiliati all’associazione e considerazione della proposta “anonima”, sottolineo le virgolette, di reclutare l’Ammazzatitani come affiliato»
Alford sbarrò gli occhi e lanciò un’occhiata sconcertata e furiosa a Philippos. Notò che il vecchio stava facendo apposta a non voltarsi mai verso di lui. Con uno sbuffo frustrato, si afferrò i capelli e li tirò con forza. Quella giornata poteva andare peggio di così? Ne dubitava molto, ma qualcosa gli diceva di non dare nulla per certo. Tuttavia, a partire da quel momento, si perse nei suoi pensieri disperati e rabbiosi, quindi perse il filo dell’aulico monologo dell’oratore. Qualche minuto dopo, alzò lo sguardo e scrutò di nuovo il tavolo dei Sapientes. Sbiancò appena vide i tre Padroni di Titani seduti su una panca a ridosso del muro opposto, intenti a fissarlo. Boyd lo salutò con la mano e fece un sorrisone innocente.
“Porca puttana” pensò Alford.
Il monologo andò avanti ancora un po’; Alford colse qualche accenno alla storia degli abitanti estinti della Terra Cava. Non si era mai interessato un granché ai cosiddetti “Aleutiani”, ma Philippos l’aveva assillato abbastanza per fargli entrare in testa alcune informazioni di base: si chiamavano così perché venivano dalle isole Aleutine, al largo dell’Alaska, prima di scendere nella Terra Cava. E poi cos’altro? Ah, giusto: avevano scoperto che la titanite permetteva di creare strumenti assurdi che pareggiavano i titani, anche se per lui erano solo fandonie.
“E magari sussurravano pure ai titani” si disse, con una risatina.
L’oratore adagiò i suoi documenti, si portò le mani dietro la schiena e continuò il discorso a braccio libero:
«E ora, prima di dichiarare aperto in via ufficiale il dibattito di selezione dei candidati, mi piacerebbe prendermi un minuto per esprimere la mia cauta preoccupazione circa la realtà politica di questo secolo che si avvicina alla sua metà esatta. Voi tutti, esimi colleghi, sapete benissimo che noi Sapientes ci siamo sempre dichiarati apolitici con orgoglio: Plinio il Vecchio radunò i membri originali dell’associazione per studiare quella parte della natura che sfuggiva più di tutte alla comprensione di noi comuni mortali, pertanto ci siamo sempre considerati esterni ai meschini intrighi di corte interni e fra le nazioni. Tuttavia, miei stimati soci, sono tormentato dal timore sempre crescente che saremmo saggi a cambiare la nostra filosofia quanto prima»
Dalla folla di eruditi si levò un gran brusio dai toni meravigliati, ai limiti dell’indignato. Suo malgrado, Alford iniziò a incuriosirsi: dopo tutto quel preambolo in pompa magna, voleva proprio sapere cosa aveva l’oratore di tanto rivoluzionario da proporre. Il Sapiens con la toga aspettò che il vociare scemasse, per poi inspirare a fondo e pronunciarsi:
«Chiunque venga eletto a nuovo Magister Sapientium, ho uno spunto di riflessione per lui: non sarebbe forse opportuno avvicinarci alle corti dei sovrani d’Europa e del mondo civile, forti del nostro prestigio scientifico e accademico, e moderare le loro ambizioni sfrenate con la nostra accortezza? Grazie ai nostri studi secolari, sappiamo meglio di chiunque altro che gli Aleutiani progredirono ben oltre i sogni più fervidi dei popoli della superficie, ma pagarono il prezzo più caro per questo. Sfruttarono il potenziale della titanite per innalzarsi al di sopra dei titani, e questi reagirono. Oggi viviamo in un mondo in cui i regnanti assoldano Padroni di Titani per accelerare il progresso delle loro nazioni e aumentarne la competitività. Il qui presente Ammazzatitani è un esempio lampante di quali sono i rischi, quando i Padroni di Titani diventano attori primari nella scena politica mondiale. Per questo reputo che dovremmo riflettere su quanto accaduto in questa porzione più recente della storia e prevenire ulteriori catastrofi»
Alford serrò le labbra e incrociò le braccia: doveva riconoscere che tutto quello che aveva detto l’oratore era la verità nuda e cruda. Negli anni che lo resero celebre come l’Ammazzatitani, non agiva per conto di qualche re. Ma cosa impediva ai sovrani di svegliarsi una mattina e mandare un Padrone di Titani al loro servizio a fare la guerra a qualche terra lontana per colonizzarla, nonostante pure quella regione fosse protetta da un titano domato? Poteva solo immaginare la distruzione che ne sarebbe derivata. Anche Boyd, Emory e Sybil dovevano star facendo lo stesso ragionamento, perché li vide confabulare tra loro con sguardi irrequieti. In tutto ciò, un piccolo pensiero confortante gli diede un po’ di sollievo: se non altro, le sue azioni passate l’avevano reso un monito vivente per i Sapientes. Se fossero diventati più coscienziosi grazie a lui, non se ne sarebbe lamentato di certo.
«Molto bene, la mia dissertazione è terminata. Coloro che si reputano all’altezza della carica, espongano i loro progetti per la nostra associazione»
Fu allora che iniziò la vera assemblea. Nel frattempo, il cielo notturno era stato coperto da una grossa nuvola passeggera, come Alford poteva vedere dalle finestre: adesso le torce non bastavano più per illuminare la sala, quindi furono chiamati i servi per accendere il camino dietro il capo del tavolo. Alford pensò di accomodarsi vicino al fuoco, ma Sybil si spostò proprio lì prima che si alzasse, quindi ci rinunciò: piuttosto che avvicinarsi a quell’oca odiosa, avrebbe potuto anche stare nudo in cima al Monte Bianco. Fece spallucce e assisté al dibattito tra gli eruditi, che però era molto più tedioso di quell’introduzione così avvincente.
In breve, i candidati si alzavano, andavano a capotavola e proponevano ai colleghi i progetti che avevano in mente per il loro mandato. Alcuni si concentravano di più sul comportamento dei titani sulla superficie, altri alla mappatura dei passaggi per la Terra Cava, altri ancora sull’archeologia nel mondo sotterraneo e così via. Alla fine della presentazione, tutti gli altri Sapientes dovevano votare per alzata di mano. C’era solo un problema: nessuna delle votazioni arrivava neanche a metà dei membri dell’associazione. I piani di ciascuno non erano abbastanza convincenti per la maggioranza. Philippos non alzò la mano neanche una volta: scuoteva sempre la testa, con fare deluso. C’era solo una cosa che impediva ad Alford di morire di noia: la curiosità di vedere se il suo amico si fosse alzato e candidato, a un certo punto. Ma quel momento sembrava non giungere mai.
“Strano, eppure mi è sempre parso un tipo da scena pubblica” pensava.
Ed ecco che arrivò una sorpresa davvero inaspettata: l’oratore si alzò dal suo posto a sedere e tutti gli sguardi si puntarono su di lui, perplessi. Il vecchio si lisciò le pieghe della toga e dichiarò:
«Miei stimati compagni, sono ben consapevole che l’associazione non ricorre a questa pratica da ormai molte elezioni del Magister Sapientium. Tuttavia, se ricordate bene il regolamento dell’assemblea selettiva, vi è la possibilità di proporre un altro membro dell’associazione, anziché se stessi. Ebbene, questa sera ho intenzione di consigliarvi il Sapiens più adeguato alla carica, ai miei occhi: mi sto riferendo a te, Philippos Papadimitriou»
Alford rimase a bocca aperta e vide Philippos trasalire e diventare più rigido di un tronco d’albero. Anche lui era rimasto spiazzato. Fino a un istante prima, era stato impegnato a scarabocchiare appunti su un quaderno ed era stato colto alla sprovvista: la penna d’oca gli scivolò tra le dita e sporcò la sua carta. Nella stanza si levò un intenso mormorio sbalordito che l’oratore dové placare battendo le mani e facendo un’espressione severa. Un anziano Sapiens cinese prese la parola, in tono garbato:
«Ricordiamo questa pratica, Dinis. Rammentiamo anche, però, che la stessa regola detta che la proposta deve essere giustificata e argomentata. Ebbene, spiegaci perché reputi Philippos il degno successore del Magister Sapientium»
D’istinto, spinto da un improvviso senso di solidarietà, Alford si alzò in piedi e si avvicinò a Philippos. Rimase accanto alla sua sedia con le braccia incrociate e rimase in ascolto. Quando lo videro muoversi, i Sapientes ebbero un lieve sussulto e le loro facce si contrassero in espressioni intimorite; alcuni tentavano di fingersi impassibili, ma invano. Philippos guardò l’Ammazzatitani con aria smarrita, per poi iniziare a strofinarsi la barba con fare ansioso. I tre Padroni di Titani, invece, seguivano con sguardi coinvolti; persino Boyd aveva smesso di ridacchiare e ruttare, rapito com’era dalla scena. Dinis si portò le mani dietro la schiena e affermò:
«Di Philippos ho sempre ammirato l’integrità, la fedeltà incrollabile alla nostra causa e al giuramento di studiare il mondo dei titani con la dovuta responsabilità. Ci meravigliammo tutti, quando prese le difese del suo protetto, l’Ammazzatitani. Non ho mai dubitato della sua capacità di giudizio e, difatti, ciò che vedo adesso mi sembra un Padrone di Titani pentito dei suoi delitti e disposto a ottenere il perdono del mondo, a dimostrazione che Philippos aveva visto qualcosa in lui che noialtri non coglievamo. Inoltre, ho appena sottolineato quanto tengo agli sviluppi politici attuali, e il nostro collega greco non mi delude nemmeno da quel punto di vista: ricordo sempre con piacere le nostre discussioni sulle iniziative dei monarchi coi Padroni di Titani. Ha uno spiccato senso critico nei confronti della società, pur mantenendosi focalizzato sui nostri studi sul comportamento dei titani, la sua specializzazione. Quale direttore migliore per tutti noi, se non un Sapiens in grado di bilanciare le ambizioni per le scoperte e le preoccupazioni per il futuro?»
Alford batté la mano sulla spalla di Philippos e gli rivolse una rapida occhiata complice; era il primo a essere contento che il suo salvatore avesse una reputazione così buona, tra i suoi soci. Il discorso di Dinis era efficace: tra gli studiosi lì riuniti iniziarono a girare commenti e cenni di assenso. L’Ammazzatitani si accorse che il suo amico stava sudando e che respirava più in fretta. Ma sorrideva. Dinis allargò le braccia e la folla si zittì ancora.
«Vedo che il consenso è generale. Tuttavia, non possiamo alzare le mani, senza l’accordo del candidato. Per questo ti chiedo, Philippos: sei disposto a farti carico della direzione dei Sapientes? Ti senti capace di diventare il nuovo erede di Plinio il Vecchio?»
Philippos deglutì e alzò lo sguardo verso Alford, come in cerca di aiuto. L’Ammazzatitani gli indicò la folla con un cenno e un sorrisetto: la scelta era sua. Dunque il vecchio greco fece un respiro agitato, si alzò con calma e fece per parlare. Ma non fece in tempo a iniziare: la porta della sala si aprì di colpo ed entrò una serva. Dinis si infastidì e le chiese in tono seccato:
«Cosa c’è?»
La serva congiunse le mani e chinò il capo con umiltà:
«Perdonate l’interruzione, illustri ospiti, ma avete un visitatore»
«Cosa? Impossibile: l’assemblea è un evento a porte chiuse»
«Ma, signore, quest’uomo afferma di essere un Sapiens. Esige che lo lasciate partecipare»
Gli studiosi seduti al tavolo ridacchiarono, come se avessero appena sentito una barzelletta. Dinis, dal canto suo, alzò gli occhi al cielo e scosse la testa:
«Dev’essere un equivoco: tutti i membri dell’associazione sono già presenti, altrimenti l’assemblea non sarebbe iniziata. Mandalo via»
La serva fece un inchino più profondo e si voltò; ma, proprio in quel momento, la porta si spalancò di colpo e nella stanza entrò un Arabo con vesti verdi raffinatissime, babbucce dorate ai piedi e un voluminoso turbante in testa. Sfoggiava una barba corta e due lunghi baffi che sporgevano ben oltre le estremità della bocca. Teneva uno sguardo altezzoso, un ghigno superbo e un’andatura disinvolta.
«Allora è così? Fingete che non sia più uno di voi?» chiese, impettito.
Tutti i Sapiens sobbalzarono, sconcertati. Philippos, invece, strinse gli occhi e i pugni: ad Alford sembrava più oltraggiato che mai. Provò a guardare i tre Padroni di Titani: si scambiavano occhiate interrogative, quindi ne sapevano quanto lui. Chi poteva mai essere quell’Arabo, per suscitare un tale fermento?
«Ahmed?!» tuonò Dinis.
L’Arabo si lisciò i baffi e iniziò a passeggiare intorno al tavolo, proprio come un leone che aggirava una mandria di zebre in cerca della preda più facile. Quando passava dietro ciascun Sapiens, le reazioni variavano: alcuni si stringevano nelle spalle come per proteggersi, altri gli lanciavano occhiate di sfida, altri guardavano altrove con sdegno. Quando Ahmed arrivò davanti al focolare, si voltò verso la tavolata e domandò con sarcasmo:
«Come state, miei vecchi compagni? Sono passati tanti anni. Avete fatto qualche scoperta davvero rilevante in mia assenza, o vi state ancora distraendo a decifrare incisioni a muro su cosa si scambiavano gli Aleutiani al mercato?»
Dinis strinse gli occhi e replicò:
«La tua presenza non è gradita qui, come non lo era quando abbiamo deciso all’unanimità di espellerti. Dicci perché hai osato farti vedere in un’occasione così importante e fallo in fretta, così che possa andartene presto»
Senza alcun ritegno, Ahmed si avvicinò a uno dei Sapientes, che si stava versando da bere, e gli sottrasse il calice. Bevve un sorso e rispose:
«Vi state scambiando pareri e proposte per scegliere il successore di colui che decide su cosa si focalizzano i nostri studi; non posso esprimere la mia modesta opinione?»
Gli ribatté un Sapiens francese:
«No. Non sei più un Sapiens. Le tue ambizioni erano un insulto alla ricerca del sapere pura e altruistica voluta da Plinio il Vecchio»
«Poco importa, condividerò la mia posizione in ogni caso: sono venuto a candidarmi a Magister Sapientium»
Come Alford si aspettava a quel punto, dalla folla si levò un baccano di esclamazioni furibonde e offese. Certi membri dell’associazione, addirittura, si alzarono in piedi e iniziarono a urlargli contro nella loro lingua madre. La situazione iniziava a non piacergli per niente: l’ultima volta che aveva visto quei vecchi sapientoni così rabbiosi era stata quando lo stavano processando. Indietreggiò fino al muro e prese a guardare la scena più in disparte. Ahmed si godeva la sfuriata di tutti con un sorrisetto compiaciuto e finì di bere. Lasciò che le acque si calmassero, prima di continuare:
«Sapete cosa penso delle vostre politiche. Non ho cambiato idea: siete un circolo di tiranni intellettuali che non smette di nascondere conoscenze inestimabili al mondo e preferite lasciare la gente bloccata a tecniche che impallidiscono, in confronto alle meraviglie di cui il popolo sotterraneo era capace. Ma tutto questo cambierà, se mi permettete di farvi da guida. Eleggetemi e farò spiccare il volo all’umanità intera!»
Fu Philippos a rispondergli, in tono pacato ma severo:
«Trascuri un particolare, Ahmed: è vero che gli Aleutiani spiccarono il volo grazie all’energia della titanite. Ma cosa fecero dopo? Volarono troppo vicino al sole, infatti sono scomparsi. Sei un illuso, se credi che la società odierna prenderebbe una direzione diversa: siamo una specie avida e ambiziosa e commettiamo sempre gli stessi errori, non appena troviamo il potere, accecati dalla superbia. È questa l’importanza di selezionare con cura le informazioni da divulgare sulla Terra Cava e quelle da nascondere, soprattutto ai sovrani»
Il sorriso di Ahmed scomparve e cedé il posto a un’espressione rancorosa. Alford riconosceva gli sguardi come quello meglio di chiunque altro. L’ospite indesiderato si avvicinò a Philippos e sibilò come una vipera:
«Aspettavo solo che ti facessi sentire. Tu, la causa della mia disgrazia!»
«Come osi lanciare accuse infondate?» si intromise Dinis.
«Credi che non lo sappia, Philippos? Fosti tu a proporre la mia espulsione per primo! E quel vecchio gracile ti ascoltò senza farsi domande. Aveva già preso la sua decisione, quando radunaste quell’assemblea fasulla!»
Philippos lo guardò negli occhi, senza battere ciglio:
«Hai ragione, Ahmed. La proposta veniva da me. E se potessi rivivere quei giorni, farei lo stesso senza indugio»
Ahmed ebbe un fremito di rabbia, dopodiché volse lo sguardo ad Alford. L’Ammazzatitani si sentì chiamato in causa e, affatto intenzionato ad apparire turbato, ricambiò l’occhiata sprezzante che l’Arabo gli stava lanciando. Ahmed scosse la testa con disappunto:
«A cosa vi siete ridotti! Non solo formate legami coi banditi che sfruttano la potenza dei titani, ma perdonate il più letale di tutti loro ed escludete l’unico tra voi ingenui che ha della vera lungimiranza! L’arretratezza della superficie si sta dilungando troppo ed è solo colpa vostra. Datemi subito l’autorità per guidare i Sapientes e abbracciate la mia visione!»
«Ci stai forse minacciando, Ahmed Ibn-Sina?» chiese Dinis.
«Preferisco definirla una condizione assoluta, ma siete liberi di considerarla una minaccia. Soprattutto perché, se rifiutate la mia richiesta, baderò da solo a garatire un futuro radioso ai popoli del mondo»
La folla si indignò ancora e Dinis urlò:
«Ora basta! Hai insultato la nostra causa e la nostra intelligenza una volta di troppo! Vattene subito, prima che chiami le guardie e ti faccia buttare sulla prima nave in partenza!»
Ahmed si lisciò i baffi, con un’espressione a metà fra il soddisfatto e il deluso:
«Immagino che non contempliate affatto la possibilità che ci sia del vero nella mia visione»
Non gli rispose nessuno. Quindi si aggiustò il turbante in testa con un sospiro e fece spallucce:
«Così sia. Forse non capite quanto è portentosa la tecnologia aleutiana perché non vi è mai importato di fare delle prove empiriche. È giunto il momento di darvi una dimostrazione»
Si infilò una mano nella manica e ne estrasse un oggetto che Alford non aveva mai visto prima: una scatoletta di ferro con una sorta di antenna da insetto e un cerchio rosso al centro. Sotto gli sguardi allibiti di tutti, sfrecciò verso la porta dopo averlo premuto. Dinis urlò di fermarlo, ma nessuno fece in tempo a trattenere Ahmed, che si dileguò. Le grida di Dinis attirarono le guardie, che furono mandate all’inseguimento.
Si diffuse un grande fermento nella sala, ma subito dopo l’attenzione dei presenti fu attirata da un bagliore viola nel cielo nuvoloso, fuori dalla finestra. All’inizio era offuscato dalla coltre di nubi e si faticava a notarlo. Ma iniziò ben presto a pulsare a un ritmo sempre più rapido e il suo colore diventava più vivido a ogni pulsazione. Dopo un minuto, divenne pure più luminoso del fuoco nel camino e colorò la sala con una lugubre atmosfera porpora.
«Che roba è?» borbottò Boyd.
Dinis impallidì:
«Quel colore! Quegli impulsi! È titanite che rilascia energia!»
I Sapientes andarono nel panico e presero ad alzarsi in fretta e furia dai loro posti. Alford aveva fiutato il pericolo dal primo istante, infatti agì senza pensarci due volte, quando il bagliore diventò accecante all’improvviso.
«Giù!» gridò.
Si fiondò verso il tavolo e placcò Philippos con un tuffo. Ignorò le esclamazioni confuse e sconvolte del vecchio amico e lo tenne a terra. Proprio allora, risuonò un fragore assordante e l’edificio tremò fino alle fondamenta. Alford strisciò sotto il tavolo e trascinò un terrorizzato Philippos con sé. Rimasero con la pancia a terra e, dal loro rifugio, osservarono l’accaduto, sconvolti: il muro esterno e il soffitto stavano crollando e le macerie che cadevano avevano spento il fuoco. I Sapientes fuggivano in tutte le direzioni, ma molti di loro non andarono lontano. Philippos distolse lo sguardo, non appena vide i suoi soci schiacciati sotto i blocchi di pietra e le travi di legno. Alford, invece, si impose di mantenere la calma e studiare la situazione, in cerca di una via d’uscita.
La luce era abbagliante ma, quando i suoi occhi vi si abituarono, riuscì a distinguere una sagoma nel cielo: la causa di tutta quella distruzione era un intenso raggio di luce viola che veniva sparato da sopra le nuvole. Era come il soffio di Godzilla, ma diverso da una fiammata: quella gli sembrava solo luce, energia pura. Il raggio si muoveva di lato e percorse tutta la lunghezza della sala; puntava al soffitto. Dopo due giri, il raggio si fermò e la quiete ritornò, macabra e terrificante.
«È finita?» balbettò Philippos.
«Così pare» rispose Alford.
Il Sapiens, che teneva la faccia premuta contro il pavimento e le mani dietro la nuca, osò sbirciare. Ora c’era un polverone che nascondeva tutto, ma si depositò in poco tempo e rivelò la devastazione della fortezza. Una manciata di Sapientes zoppicava e tossiva tra le macerie; erano tutti feriti e mormoravano con angoscia i nomi dei loro compagni, quando notavano un braccio o una testa che sporgeva dalle macerie. Alford gattonò oltre il tavolo e si alzò in piedi.
“Porca di quella…” pensò.
Davanti a lui, si stagliava il panorama dell’oceano di notte, illuminato da uno spicchio di luna tra le nuvole. Era come un vasto quadro dalla cornice di mattoni sgretolati: ora alla fortezza mancava tutta la parete rivolta verso la costa. La situazione si era ribaltata del tutto in una manciata di secondi. Avrebbe dovuto capire che Ahmed non era venuto solo a fare lo spaccone. Philippos lo raggiunse poco dopo e Alford squadrò l’amico: tremava ed era pallido. Farfugliava mormorii insensati, senza riuscire a comporre le frasi. Alford meditò su cosa fare o dirgli, ma sentì una voce femminile tossire poco lontano e si voltò per guardare. Boyd ed Emory stavano dando una mano a una Sybil scombussolata e ferita a un fianco.
«È grave?» chiese loro.
La sua preoccupazione era sincera, ma la donna doveva aver interpretato la domanda come una provocazione, infatti sputò per terra dopo averlo guardato furiosa.
“Non si smentisce” pensò Alford.
In quel momento, sentì un frastuono acuto dal cielo. La coltre di nuvole si aprì e apparve la cosa più bizzarra che Alford avesse mai visto: una barca di metallo che si librava a mezz’aria, spinta da quattro fornaci che eruttavano fiammate viola potentissime. Il “cuore” di quella meraviglia meccanica sembrava un grande impianto al centro della barca fatto di complessi meccanismi in continuo movimento, da cui scaturiva la stessa luce viola del raggio. Senza pensarci due volte, l’Ammazzatitani prese la sua conchiglia, inspirò a fondo e vi soffiò dentro. Sperava solo che Godzilla non fosse partito per uno dei suoi “giri costieri” nel frattempo.
«Un aeroscafo aleutiano!» esclamò un Sapiens.
La barca volante emise un fischio acutissimo che, a poco a poco, divenne un ronzio; a quel punto, un bizzarro apparecchio a cono sulla prua trasmise la voce di Ahmed, che rimbombò come un tuono imperioso e trionfante:
«Avete appena assistito a una meraviglia ingegneristica su cui ho lavorato di persona negli ultimi anni. Sarei stato ben lieto di presentarvelo in un contesto molto più pacifico, ma ahimè, vi siete dichiarati miei nemici nel momento in cui mi avete punito per volere il meglio per la gente»
Si aprì uno sportello sotto la chiglia e fuoriuscì un cannone dalla canna a spirale; l’arma iniziò a caricarsi e lo stesso bagliore ritmato di prima tornò ad accecare tutti.
“Andiamo, amico mio, dove sei?” pensò Alford, teso.
Intanto, la voce di Ahmed continuava a predicare:
«Ho grandi progetti per sensibilizzare i popoli delle grandi nazioni sui prodigi concepiti dagli Aleutiani, e sarà molto meno faticoso metterli in pratica senza la vostra esecrabile cerchia tra i piedi. Vi prego di comprendere. Molto presto, unificherò la società contro il suo più grande nemico da sempre: le bestie colossali che per secoli ci hanno tenuti nell’ombra e nella paura!»
A quel punto, il cannone cambiò angolazione e puntò in una direzione ben precisa: verso i tre Padroni di Titani. Boyd, Emory e Sybil sobbalzarono. Dopo un attimo di stupore, la donna esortò i compagni a scappare. Fecero un tentativo di allontanarsi, ma l’arma seguiva i loro movimenti. Quindi Emory esclamò di dividersi e gli altri due non persero tempo. Il rosso si gettò dietro un cumulo di macerie, mentre Sybil strisciò sotto il tavolo con una mano premuta sulla ferita. Fu allora che Alford trasalì: Boyd era ancora ubriaco. Non riusciva a fuggire, barcollava fra i detriti e cambiava idea di continuo su dove andare. Stava perdendo tempo. Intanto, la voce di Ahmed concluse:
«Com’è ovvio, ciò significa che coi titani dovranno sparire anche i loro domatori e sfruttatori. Vedrete che sarà un mondo migliore, una volta eliminati tutti. Addio»
La luce del cannone smise di pulsare e diventò un lampo accecante, come la prima volta. Era puntata su Boyd, che cadde in ginocchio e si riparò la faccia, tra i singhiozzi di disperazione. In un baleno, qualcosa scattò nella mente di Alford e, nonostante la frenesia della situazione, l’Ammazzatitani agì. Scattò verso Boyd con l’agilità di un atleta, gli afferrò la collottola e, con tutte le sue forze, lo trascinò con sé a ridosso di un pezzo di muro che aveva resistito.
«Eh? Cosa? Tu?» biascicò Boyd.
«Arriva!»
Tuttavia, non avvertirono alcun impatto. Invece, la notte fu illuminata da una fredda luce azzurra e nell’aria fece eco un’esplosione. Alford sbirciò oltre il muro crollato ed esultò: la barca volante era stava colpita da un’intensa fiamma blu che le aveva dato fuoco. Le fiamme avvolsero il vascello di metallo, dopodiché le luci delle armi su di essa sfarfallarono e un’improvvisa deflagrazione violacea sfasciò del tutto l’aeroscafo. Il mezzo diventò una cometa infuocata e planò lungo la costa, per poi schiantarsi e lasciare un solco sul suo percorso.
«Siamo salvi!» esclamò un Sapiens, estasiato.
La terra tremò e Godzilla apparve dalla costa, a passo trionfale. La sua cresta e i suoi occhi brillavano ancora di azzurro, in netto contrasto con la luce rossa e calda degli incendi. Il titano si avvicinò alle rovine e si chinò per avvicinare il muso al suo padrone. Gli soffiò in faccia e gli rivolse un brontolio preoccupato. Alford accarezzò la punta del suo naso e lo rassicurò:
«Sto bene, tranquillo. Bella mossa, Godzy»
Il bagliore azzurro si spense poco a poco e il Gojirasauro esalò un’ultima vampata di fumo radioattivo. Con un ringhio, si avvicinò al relitto dell’aeroscafo e lo calpestò con violenza, quindi lanciò un glorioso ruggito al cielo. Dopo aver dimostrato chi comandava, afferrò i rottami con una zampa e staccò alcuni pezzi: si mise a masticare le armi alla titanite.
«È stata la cosa più assurda, spaventosa e impressionante che abbia mai visto. E per stupirmi ce ne vuole!» fu il commento di Emory.
Boyd era ancora spaparanzato a ridosso del muro, con gli occhi sgranati e il batticuore; si teneva una mano sul petto, che si alzava e abbassava a un ritmo frenetico. Alford gli porse la mano e lo aiutò ad alzarsi. Il biondo lo fissò basito e mormorò:
«Mi hai salvato la vita?»
Alford fece spallucce:
«Ne avevo l’occasione, così non ho perso tempo»
«Ah!»
«Che c’è?»
«Ne parli come se fosse normalissimo. Mi pare assurdo, per uno come te»
Alford annuì, comprensivo. Lanciò un’occhiata offesa a Sybil e non perse l’occasione di rimarcare:
«Philippos non vi mente: voglio davvero riparare ai danni che ho fatto. Quello che vi ho detto prima era solo la mia rabbia. Detesto essere costretto a ricordare tutti i miei sbagli»
Boyd iniziò a singhiozzare come un bamboccione e lo colse alla sprovvista con un poderoso abbraccio. Alford si irrigidì, sia per l’imbarazzo sia per la stretta incredibile del grassone. Quando fu lasciato andare, non pochi secondi dopo, Emory si fece avanti e lo guardò negli occhi:
«Se non fosse stato per te, stasera avrei perso un altro caro amico. Non lo dimenticherò»
«Figurati»
«Suppongo che meriti la fiducia di tutti noi. Vero, Sybil?»
Il rosso rivolse un’occhiata severa alla donna. Sybil digrignò i denti e strinse il pugno, insozzato di sangue come il suo kimono per aver tamponato la ferita. Alla fine, sbuffò e dichiarò:
«Un salvataggio eroico non compensa neanche uno dei tuoi crimini, sappilo. Ma sì, forse ora potrei crederci»
Boyd ridacchiò e aggiunse:
«Vuol dire “ci sto” in sibillino»
Alford sorrise e annuì in segno di gratitudine. Si guardò in giro: i Sapientes si erano pressoché dimezzati. Ora erano giunte le guardie e i servi, che stavano portando via i feriti. Erano ridotti tutti male. Si rivolse a Sybil:
«La polvere curativa della tua Mothra farebbe comodo a tutti in questo momento. Che aspetti a chiamarla?»
La donna diventò rossa in viso e distolse lo sguardo. Con lei, anche Boyd ed Emory mostrarono segni di disagio e imbarazzo. Alford li guardò con un’espressione confusa e allargò le braccia:
«Be’?»
«I nostri titani non sono qui» confessò lei.
«In che senso? Sono sulle altre isole?»
«No. Non sono alle Azzorre. Siamo venuti da soli»
Alford era esterrefatto:
«Cosa?! Che razza di Padrone di Titani si separa dal suo compagno?!»
«Philippos ci ha detto che ci saresti stato tu! Che ti aspettavi?»
«Ma… ma… che…»
Alford si buttò le mani nei capelli e soffocò la sequela di imprecazioni che stava per esclamare a pieni polmoni. Pure a quello si spingevano, i pregiudizi su di lui. C’era da aspettarselo, ma non aveva parole. Alla fine, fece finta di niente e si allontanò dal trio, preoccupato di cosa avrebbe potuto dire loro. Vide Philippos seduto su un blocco di pietra e gli si avvicinò. Il vecchio stava con la schiena curva, la bocca coperta dalle mani e i gomiti appoggiati sulle ginocchia. Sembrava rimuginare su qualcosa. Alford voleva vederci più chiaro:
«Chi è questo Ahmed? Perché l’avete buttato fuori?»
«Le azioni di cui è capace non sono abbastanza rivelatorie per te?»
«Uhm… giusto»
«Così tante vittime! È il colpo più duro mai sofferto dall’associazione in tutta la sua storia. Nemmeno la Santa Inquisizione nel Medioevo e le prime spedizioni impreparate nella Terra Cava ne hanno mietute così tante fra noi. Miserabile assassino spregevole! Non solo ostacola l’elezione del Magister Sapientium, ma si appropria degli strumenti di morte del popolo sotterraneo e li usa contro di noi!»
«Gli ho sfondato quel giocattolo volante. Siamo a posto, no?»
Philippos alzò lo sguardo, allarmato:
«Niente affatto, Alford. Hai sentito la sua dichiarazione d’intenti: Ahmed ha grandi progetti, piani così ambiziosi che riguardano ogni popolazione del globo. Questo attacco non era che un preambolo»
«E quindi?»
«Dobbiamo agire in fretta. Piangere i nostri caduti, riorganizzarci e cercare di capire quale potrebbe essere la sua prossima mossa. Ascoltami bene, Alford: quando si tratta di re e titani, le vite di tutti potrebbero cambiare per sempre, senza che abbiamo voce in capitolo»
«Capisco. C’è qualcosa che posso fare?»
«Non ti preoccupare. Gli hai impedito di ucciderci tutti: questo era già il massimo che potevi fare. Ti ringrazio, a nome di tutti i Sapientes. Non ho mai dubitato della tua bontà di fondo, ragazzo mio»
L’Ammazzatitani avvertì un nodo alla gola. Chinò il capo in silenzio, alzò la mano per congedarsi e si allontanò dalla fortezza. Uscì direttamente dal muro crollato. Iniziò una silenziosa passeggiata solitaria lungo la cresta della costa rocciosa, mentre inspirava a fondo la fresca e frizzante aria oceanica e ascoltava la melodia delle onde. Ripensava al suo ultimo scambio coi tre Padroni di Titani. Quella giornata era stata un turbine impazzito di emozioni miste, ma quella svolta finale gli aveva dato qualcosa di prezioso: un barlume di vera speranza. Si era guadagnato la fiducia delle persone che lo odiavano più di chiunque altro, a ragione. Non avrebbe sprecato quella possibilità per nulla al mondo.
Chapter 4: Ivan il Pazzo
Chapter by Roberto_Turati
Chapter Text
Dalla turbina provenne un altro scoppio preoccupante e Ahmed sobbalzò al timone per lo spavento: e se la fortuna l’avesse abbandonato? Fermò l’aeroscafo a mezz’aria, si bardò con le protezioni per proteggersi dall’energia della titanite e controllò il motore antico. Dopo un attento controllo, tirò un sospiro di sollievo: poteva continuare a volare. Maledisse a denti stretti l’Ammazzatitani: avrebbe dovuto uccidere tutti i Sapientes quella sera, con tanto di tre Padroni di Titani, ma quel dannato eremita si era inserito nell’equazione e aveva interrotto l’attacco. Questo non l’avrebbe certo fermato, anzi: aveva reso più facile la sua prossima mossa. Tuttavia, era comunque pericoloso volare con un aeroscafo danneggiato senza mai ripararlo. Gli serviva rotto.
“Se solo potessi rischiare di volare alla massima velocità!” pensò.
Volava senza sosta da settimane, ormai. Una volta lasciate le Azzorre, aveva seguito la costa atlantica dell’Africa fino a Gibilterra, poi aveva attraversato il Mediterraneo da occidente a oriente e, per gli ultimi giorni, aveva sorvolato l’immensa taiga della Siberia. Era la parte più monotona del viaggio: il paesaggio era sempre uguale, la distesa di pini era sconfinata e l’aria fredda gli penetrava nel corpo fino alle ossa. Oltretutto, le sue provviste iniziavano a scarseggiare. A volte Ahmed aveva la sensazione di stare per impazzire, ma teneva duro ricordandosi che serviva tutto a spalancare le porte a un futuro rivoluzionario.
“Il minimo che mi sarà dovuto è dare il mio nome alla prima generazione di nuovi apparecchi alla titanite” si diceva, sognante.
Ma per ora, era meglio concentrarsi sul presente: aveva una destinazione ben precisa, nel cuore della Siberia. Finalmente, il suo lungo viaggio volse al termine: una mattina, dopo l’alba, Ahmed si ritrovò a sorvolare l’immenso fiume Enisej, il più lungo della Russia. Emozionato, svoltò verso nord e iniziò a seguire il corso del fiume artico, resistendo alla tentazione di accelerare per giungere prima a destinazione. A mezzogiorno, avvistò quello che stava cercando: un’isola abitata in mezzo al fiume. Lì sorgeva Svobodaburgo, o la “città libera dei fuorilegge”, com’era chiamata nei racconti. Ahmed fece manovra e si fermò a bassa quota sopra l’isola: voleva osservare il posto dall’alto, prima di atterrare e interagire con la gente del posto.
Doveva ammettere di essere stupefatto: non era affatto come l’aveva immaginata. Svobodaburgo era un raduno di criminali, reietti, banditi da ogni angolo del mondo. Tutti la figuravano come un’accozzaglia di bettole cadenti, abitate da barbari sudici e incivili che si sgozzavano a vicenda come animali. Cosa si trovava di fronte, invece? Un borgo ridente abitato da quella che sembrava una comunità normalissima, composta persino da bambini che giocavano per strada. Le abitazioni erano raffinate e di bell’aspetto, gli abitanti visti da lontano sembravano impegnati nelle tipiche attività delle cittadine e, poco lontano dall’insediamento, si ergeva uno splendido palazzo che sembrava la reggia di un re. Ma ciò che saltava più all’occhio era quello che stava al centro di Svobodaburgo: un enorme cumulo d’oro e pietre preziose nella piazza principale, fatto di manufatti di gioielleria impilati l’uno sull’altro. Il mucchio era circolare e concavo: sembrava un gigantesco nido di ricchezza.
“Di certo i fondi non mancano” pensò Ahmed, con una smorfia.
Sapeva bene com’era possibile quel benessere; lo sapevano tutti. E si sapeva anche chi spingeva i fuorilegge a compiere un pellegrinaggio lunghissimo e pericoloso fino alla Siberia, in cerca di un rifugio sicuro: erano tutti attratti dalla promessa di un’uomo. Non un uomo qualunque: era considerato da chiunque la persona più pericolosa al mondo, nonché il Padrone di Titani più distruttivo. Ivan il Pazzo. Era lui che, col suo titano, terrorizzava intere nazioni e costringeva re e imperatori a consegnargli tutte le ricchezze che esigeva come tributo, in cambio di non essere spazzati via. E sempre lui aveva fondato Svobodaburgo, un’utopia per fuggitivi e reietti che cercavano la sua protezione. Grazie a Ivan il Pazzo, ora erano diventati una “società” autonoma che si manteneva con le ruberie del loro protettore. E sarebbe stato proprio lui che avrebbe aiutato Ahmed a chiudere l’era dei titani e guidare l’umanità verso un nuovo mondo.
“Si comincia ora” pensò l’ex Sapiens.
Si accorse solo allora che gli abitanti di Svobodaburgo si erano radunati tutti nella piazza centrale per guardarlo. Li comprendeva: una meraviglia tecnologica come l’aeroscafo aleutiano doveva sembrare miracoloso, agli occhi dei comuni mortali. Ahmed armeggiò coi comandi e planò verso le rive dell’isola, vicino alle prime case. Finalmente, il motore poteva riposare in pace finché non l’avrebbe riparato. Non rischiava più di esplodere, ma ora doveva vedersela coi locali. Ben presto, fu raggiunto di corsa da un manipolo di guardie armate di spada, che gli puntarono le lame contro e iniziarono a sbraitare in russo. Ahmed aveva studiato la lingua per un anno intero, prima di attuare il suo piano: era il momento di mettere in pratica quello che aveva imparato.
«Vengo in pace, onorevoli guardiani! Non abbiate paura del mio insolito veicolo: è solo un mezzo di trasporto. Certo, è un mezzo che sfida la gravità, ma nulla di più»
Non poteva certo fare menzione del cannone alla titanite. Alcune guardie gli girarono intorno e iniziarono a osservare l’aeroscafo con timorosa curiosità, mentre le altre continuarono a tenere d’occhio Ahmed. Mentre pensava a qualcos’altro da dire per rassicurarli, arrivò una guardia con un’armatura d’argento e un mantello dorato: sembrava un superiore. A giudicare dai lineamenti, gli sembrava medio-orientale. Il capo delle guardie squadrò Ahmed da capo a piedi, dopodiché lo sorprese parlando in turco:
«Capisci quello che dico?»
«Sì, certo»
Ahmed nascose un sospiro di sollievo: lo metteva molto più a suo agio parlare nella sua seconda lingua. Il capo delle guardie annuì e ordinò:
«Dimmi chi sei e che intenzioni hai»
«Come desideri: sono Ahmed Ibn-Sina, appassionato membro dell’associazione dei Sapientes. Ho un messaggio di vitale importanza per il vostro augusto signore»
Non importava quello che i “sapienti” pensavano delle sue idee e della sua visione, lui era un Sapiens degno di quel nome, e presto l’avrebbe dimostrato a tutti. Il capo delle guardie incrociò le braccia, diffidente:
«Solo chi desidera ricominciare con una nuova vita, libero dalle leggi dei regni e al sicuro dalla ferocia umana, può sbarcare su quest’isola. Sappi che il modo… ehm… insolito con cui sei arrivato è l’unica cosa che ti ha permesso di arrivare fin qui»
Ahmed fece un passo indietro, chinò il capo e alzò le mani:
«Sono desolato per aver infranto le vostre usanze e chiedo perdono. Tuttavia, ritengo che l’emergenza di cui devo avvertire il vostro generoso protettore sia tale da giustificare qualsivoglia irregolarità»
Sperava che il suo linguaggio forbito e ricercato gli conferisse abbastanza autorevolezza da persuadere quei sempliciotti in armatura. Il capo delle guardie iniziò a rimuginare; osservò a lungo sia lui sia l’aeroscafo fumante e mezzo sfasciato. A un certo punto, sebbene la sua espressione fosse ancora sospettosa, diede un ordine in russo e le guardie se ne andarono. Il loro capo si voltò e gli fece un cenno:
«Seguimi e non allontanarti da me»
«Ma certo. Ti ringrazio per la comprensività, egregio…»
«Çelik»
«Egregio Çelik. C’è una tempesta all’orizzonte, amico mio: bisogna prepararsi»
Il capo delle guardie scoppiò a ridere:
«Oh, la tempesta all’orizzonte ci sarà eccome, quando Ivan tornerà. Lo vedrai»
«Dunque non è presente?»
«È andato a riscuotere un tributo in India, ma prevediamo che torni proprio oggi. Hai avuto un ottimo tempismo, Ahmed. Sono proprio curioso di sapere cos’ha un Sapiens da dirgli!»
«Molto bene, approfitterò dell’attesa per dare un’occhiata più attenta alla vostra comunità, se non è un problema»
Mentre Çelik scortava Ahmed attraverso le strade di Svobodaburgo, l’ex Sapiens provò ad analizzarlo in base al ruolo che ricopriva e al suo atteggiamento: se Ivan il Pazzo era la massima autorità e quelle guardie erano l’unico gruppo che facevano rispettare la sua volontà, era probabile che Çelik fosse la seconda figura più importante dell’insediamento, motivo per cui parlava così tanto e con quella disinvoltura, di fronte a un visitatore inatteso. Forse lo considerava una mosca che si era posata su un bue. Be’, che lo credesse quanto voleva: prima o poi, avrebbero parlato i fatti per Ahmed.
Mentre seguiva il capo delle guardie, Ahmed ebbe modo di osservare più da vicino Svobodaburgo. La folla di curiosi si era dispersa, ma tutti stavano solo fingendo di svolgere le loro attività quotidiane: tutti gli sguardi erano puntati su di lui, tra curiosità e sospetto. L’ex Sapiens notò subito una cosa: l’immagine di Ivan il Pazzo era ovunque. Tra murali sulle case, statue d’oro massiccio e citazioni delle sue parole su grossi cartelli, il fondatore di quell’utopia per banditi sembrava onnipresente nonostante fosse in viaggio. Era incredibile: il suo patrimonio era tale che aveva potuto sia dare un aspetto civile al suo covo sperduto sia alimentare il suo ego con tutto quel lusso. In tutte le sue rappresentazioni, Ivan indossava una pacchiana armatura dorata che sembrava uscita da un racconto di fantasia ed era armato di una spada altrettanto appariscente.
«Non posso fare a meno di notare che il venerabile Ivan ha a cuore la propria immagine» commentò.
Çelik annuì:
«Vuole essere sempre in mezzo a noi, così che tutti si ricordino chi devono ringraziare per tutto questo benessere e sicurezza. Inoltre, vuole che i nostri figli imparino dalla sua saggezza. Ecco, lo puoi vedere proprio laggiù»
Il capo delle guardie indicò un cortiletto in fondo a un vicolo, dove un maestro stava facendo una lettura a una scolaresca di bambini. Ahmed tese l’orecchio e colse alcune frasi che gli parvero familiari: l’insegnante stava spiegando agli allievi che l’uomo era un lupo per gli altri uomini. Gli ricordava qualcosa. Alzò gli occhi al cielo: per forza un egocentrico come Ivan il Pazzo faceva pure indottrinamento. Tipico dei Padroni di Titani: in un modo o nell’altro, credevano tutti che il mondo ruotasse intorno a loro. Quanto gli facevano pena. Mentre rimuginava, i due raggiunsero l’enorme “nido” d’oro e gioielli e Çelik disse ad Ahmed che avrebbero aspettato lì fino al ritorno di Ivan.
«Sono davvero ansioso di consegnargli il mio messaggio» affermò Ahmed, con un sorriso forzato.
Si sedé su una panca ai margini della piazza principale e Çelik continuava a tenerlo d’occhio, impassibile. Un manipolo di guardie si unì a lui a poco a poco. Ahmed temeva che quell’attesa si prolungasse troppo, ma per fortuna il momento giunse dopo appena un’ora. Tutto iniziò quando il vento cambiò direzione all’improvviso e divenne molto più forte: le chiome dei pini intorno all’insediamento si piegavano con le folate; Ahmed doveva tenersi il turbante, per non lasciarlo volare via. Il cielo si rannuvolò in pochi minuti e dei tuoni cominciarono a rimbombare da sud.
Ahmed sapeva benissimo cosa stava arrivando e fremeva dall’emozione: per quanto disprezzasse i titani, non poteva negare che vederne uno da vicino fosse affascinante. Tra le nuvole iniziarono a brillare dei lampi gialli; dapprima si vedevano appena all’orizzonte, ma si avvicinarono in poco tempo e i tuoni diventavano sempre più assordanti. Alla fine, quella tempesta che sembrava quasi innaturale raggiunse Svobodaburgo e il vento diventò potentissimo. Fulmini dorati cominciarono a saettare tra le nuvole e alcuni folgorarono le punte dei pini. Cominciò a piovere e la gente, che si era già rifugiata in casa, chiuse tutte le porte e finestre.
«Prepararsi!» ordinò Çelik.
Le nuvole scesero sull’insediamento e velarono ogni cosa: Ahmed non riusciva a vedere a un palmo dal naso. Qualcosa si schiantò davanti a loro con un tonfo profondo e la terra tremò. I fulmini rivelarono per un attimo un’ombra gigantesca nella foschia e Ahmed cominciò a udire dei sibili di serpente, uniti a ringhi ticchettanti. Di colpo, brusca com’era arrivata, la tempesta si dissipò: smise di piovere, tuoni e fulmini cessarono, il vento si placò e cadde il silenzio. Le nuvole si diradarono e rivelarono la creatura: una colossale viverna gialla con tre lunghi colli e due code a sonagli, alta quaranta metri. Un Ghidorah.
“Straordinario!” pensò Ahmed.
Con un lieve battito d’ali, il Ghidorah disperse l’ultimo velo di nubi e si rivelò in tutta la sua imponenza. Stringeva qualcosa con una zampa: un grande sacco gonfio da scoppiare, da cui provenivano suoni tintinnanti. Il titano allontanò il sacco con un calcio distratto e si posizionò al centro del grande cumulo d’oro, rivelando così il suo scopo: era il suo posatoio. Mentre osservava con attenzione quel mostro dall’anatomia assurda, Ahmed notò una sagoma tra le corna della testa centrale: un uomo in armatura. La stessa armatura stravagante delle statue e dei murali; era Ivan il Pazzo. Il Ghidorah avvicinò le teste al suolo e il suo padrone saltò sul mucchio d’oro. Stette in piedi sul margine del nido e gridò a gran voce, in russo:
«Il vostro leviatano è tornato, miei protetti!»
“Leviatano?” pensò Ahmed.
All’improvviso, unì i puntini con quello che aveva origliato prima e capì molte cose: Ivan doveva aver fondato la sua piccola autocrazia sul pensiero di Thomas Hobbes, un filosofo inglese del secolo precedente. Ahmed ricordava di aver ascoltato una spiegazione delle sue tesi tempo prima, da un Sapiens tedesco fissato con la filosofia. Trattenne una smorfia: se Ivan si considerava il leviatano del “patto sociale”, scommetteva che non contemplava il piccolo dettaglio che il popolo poteva revocare il potere al capo assoluto in qualunque momento. Ma d’altronde, chi avrebbe mai osato sfidare il titano più letale del pianeta? Intanto, Ivan aggiunse:
«Porto con me il bottino dall’India! Come promesso, sarà usato subito per costruire il nostro primo sanatorio! Finalmente i nostri malati avranno una speranza in più, grazie alla mia lungimiranza e benevolenza!»
A quel punto gli abitanti di Svobodaburgo, che già facevano capolino dalle loro finestre, uscirono e si radunarono intorno al nido del Ghidorah per applaudire e osannare il loro governatore. Le tre teste del titano guardavano la folla ed emettevano versi gutturali, mentre Ivan si inchinava e ringraziava i suoi sudditi delle lodi. Ahmed decise che non avrebbe aspettato oltre: si fece largo tra la folla e si avvicinò il più possibile al cumulo. Tuttavia, attirare l’attenzione del Pazzo si rivelò più difficile del previsto: il baccano della folla che inneggiava era troppo forte e Ivan era concentrato sull’autocelebrarsi. Alla fine, però, si fece notare la qualcuno: la testa sinistra del Ghidorah posò lo sguardo su di lui e fece subito un’espressione incuriosita. Ahmed sudò freddo, intimidito, e fece dei passi indietro. La testa sinistra si abbassò subito per annusarlo, ma la testa di destra le rivolse un sibilo rabbioso e la testa centrale le morse le corna in segno di rimprovero.
“È proprio come nei testi aleutiani: ogni testa è un’entità separata” rifletté Ahmed, impressionato.
Ivan il Pazzo si accorse del bisticcio con se stesso del suo titano e si voltò, perplesso:
«Che problema c’è, Molnii? Qualcosa non va?»
Le tre teste si misero subito sull’attenti, quando il padrone si rivolse a loro. Con fare timoroso, la testa di sinistra si abbassò ancora e indicò Ahmed con un cenno del muso. Ivan si voltò, scrutò la folla e si accorse dell’unico estraneo. Ebbe un fremito e strinse i pugni; dopodiché, con molta calma, si tolse l’elmo della sua bizzarra armatura e rivelò il suo volto: era un quarantenne biondo coi capelli lunghi e fluenti, coi baffi curati e il resto della barba rasato. Senza staccare lo sguardo da Ahmed, Ivan il Pazzo scese dal cumulo d’oro e la folla fece un timoroso passo indietro; l’ex Sapiens, invece, non osò muoversi e si irrigidì come un tronco. Cos’aveva in mente? Ivan avanzò verso di lui con l’elmo sottobraccio e gli girò intorno, come un predatore che studiava il suo prossimo pasto. Dopodiché, il signore di Svobodaburgo cercò le sue guardie con gli occhi e li strinse, quando adocchiò il loro capo.
«Çelik!» sbraitò.
Il diretto interessato impallidì e si affrettò ad avvicinarsi, con un inchino:
«Mio sovrano?»
«Sai che conosco ogni singolo membro di questa comunità, dal più vecchio al più giovane, vero?»
«Sì, mio sovrano»
«Eppure non conosco quest’Arabo. Questo fa di lui un estraneo, dico bene?»
«Sì, mio sovrano»
«Questo mi fa sorgere un dubbio, Çelik: ho forse cambiato la legge, prima di partire per l’India?»
«No, mio sovrano»
«Allora vige ancora la regola per cui nessuno, ripeto, nessuno può mettere piede su quest’isola senza la mia approvazione personale. Allora dimmi, mio secondo in comando, che ci fa costui nel mio dominio senza il mio permesso?»
«Mio sovrano, dice di avere…»
«Molnii!» esclamò Ivan.
Il Ghidorah sibilò con le sue tre lingue biforcute e il suo padrone indicò il capo delle guardie. Tra le guardie si levò un brusio sconvolto, mentre gli abitanti della comunità chinarono subito gli sguardi, impauriti e dispiaciuti. Çelik si buttò in ginocchio e farfugliò:
«Mio sovrano, aspettate! L’ho fatto entrare solo…»
La sua frase fu interrotta quando la testa centrale del Ghidorah scattò fino a terra e lo afferrò con la bocca. Si potevano sentire le atroci grida di dolore del malcapitato, ovattate dalle fauci. La testa centrale si risollevò, strinse la morsa e le gambe di Çelik si staccarono. Le altre due teste afferrarono al volo ciascuna e la ingoiarono, mentre la testa centrale si rigirava il corpo in bocca per scartare la corazza e il mantello. Ahmed dové fare uno sforzo immenso per mantenere la calma e non mostrare segni di panico: se la vita di tutti i presenti dipendeva davvero da un semplice sbalzo d’umore del “leviatano”, doveva stare attentissimo e misurare con cura tutte le sue prossime parole. Non osava neanche asciugarsi il sudore dalla fronte. Ivan sospirò, poi si avvicinò a una guardia coi capelli rossi e gli diede una pacca sulla spalla con un sorrisetto:
«Francisco, ora sei tu il mio secondo in comando. Congratulazioni! Rompete le righe»
Ahmed era sconvolto dalla disinvoltura con cui parlava dopo aver fatto una cosa del genere. Si era davvero guadagnato il suo titolo. Dopo quella sostituzione lampo, Ivan si rivolse alla folla e annunciò:
«Miei protetti, purtroppo non sono più dell’umore adatto per celebrare oggi stesso la mia ultima impresa. Ma non temete: i canti, le danze e le bevande ci attendono domani, e sarà festa fino al tramonto!»
La folla parve incerta in un primo momento, ma quando Ivan alzò un sopracciglio come per esigere una reazione, esultarono tutti ancora una volta. Dopo l’ennesima ondata di ovazioni, Ivan fece un cenno di congedo e tutti gli abitanti lasciarono la piazza per riprendere le loro attività giornaliere. A quel punto, Ivan e Ahmed erano gli unici presenti, oltre al Ghidorah.
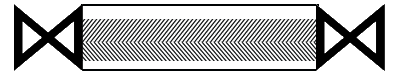
Ivan si strofinò gli occhi con uno sbuffo: non poteva lasciare le sue guardie sole un minuto. Gli sarebbe piaciuto tanto imporre la sua legge di persona tutto il tempo, ma doveva pur sempre reclamare bottini dai falsi leviatani del mondo per mantenere in buono stato Svobodaburgo e farla prosperare. Quell’idiota di Çelik gli aveva proprio rovinato la giornata, e già era nervoso per il lungo volo. Non voleva fare altro che chiudersi nel suo palazzo per il resto del pomeriggio e osservare la sua comunità dalla balconata frontale, quindi voleva risolvere la questione del visitatore il più in fretta possibile. Rifletté un attimo su cosa fare con lui: dapprima, pensò di farlo fulminare. Ma poi preferì trovare un valido motivo per condannarlo a morte, quindi sfoggiò il suo sorriso più accogliente e disse:
«Çelik stava dicendo qualcosa sulle tue intenzioni. Saresti così cordiale da condividerle con me, così che possa giudicare la tua presenza qui? Oh, ma che sbadato! Non ti ho chiesto neanche come ti chiami!»
L’estraneo fece un respiro agitato e rispose in tono cauto:
«Ahmed Ibn-Sina, sono un Sapiens dalla Mecca. Ho viaggiato fino alla tua terra per informarti di certe novità enormi che potrebbero coinvolgerti in futuro»
«Sei venuto fin qui solo per dirmi le ultime notizie? Come sei premuroso! Dev’essere qualcosa di epocale»
Ahmed annuì:
«Non avresti potuto usare una parola più adeguata: “epocale”. Come ben sai, è ormai la norma che i sovrani delle nazioni del mondo stringano un’alleanza privata con un Padrone di Titani per sostenere la loro economia»
«Oh, sono il primo a saperlo! Sono patetici, non trovi? Quei Padroni di Titani, intendo. Potrebbero schiacciare quei “governatori” autoproclamati come mosche e prendersi tutto quello che vogliono dai loro popoli, invece si mettono a servirli! Che razza di sistema è?»
«Ecco, temo che i servigi dei Padroni di Titani stiano per raggiungere vastità senza precedenti: gira voce, infatti, che i sovrani d’Europa, Africa e Asia stiano progettando di radunare un immenso esercito comune, coi titani a loro sottomessi in prima fila, con un solo scopo: marciare su queste terre e distruggere te e la tua maestosa cavalcatura»
Non appena sentì quelle parole, Ivan non seppe trattenere l’impulso di ridere e scoppiò in una risata così fragorosa che si piegò in due davanti all’ospite e gli venne il singhiozzo. Allora le risate cederono il posto all’imbarazzo e Ivan guardò oltre le spalle di Ahmed con preoccupazione: non voleva che i suoi sudditi lo vedessero così. Alle sue spalle, Molnii emise dei ticchettii preoccupati, ma Ivan alzò la mano per calmarlo e fece dei respiri lenti e profondi per riprendere il controllo. Si asciugò le lacrime dovute alle risate e batté la mano sulla spalla di Ahmed:
«Amico mio, sei un pazzo scatenato!»
Il Sapiens gli rivolse un’occhiata perplessa:
«Non capisco. Cosa fa di me un pazzo?»
«Quanti mesi ti ci saranno voluti per venire qui? Non è garantito sopravvivere a un simile viaggio! Eppure hai fatto tutta questa strada solo per raccontarmi questa barzelletta? Sei un folle! Però devo dire che non ridevo così da parecchi anni: sei un comico di talento, te lo riconosco. Potrei fare di te l’intrattenitore ufficiale di Svobodaburgo! La mia gente non ha tanti mezzi per svagarsi qui, a parte l’alcol e le donne»
L’espressione dell’Arabo diventò esterrefatta e, a tratti, offesa, cosa che a Ivan non piacque affatto. Ahmed si schiarì la voce e affermò:
«Sono lieto di averti fatto divertire con efficacia, ma purtroppo le mie parole sono serie, come lo è la faccenda che si sta svolgendo in questo momento nelle corti dei re. Ci sono voluti anni di preparazioni, assemblee e prese di posizione, prima che si arrivasse a questo, ma hanno promosso quest’operazione fino in fondo. Non manca molto, prima che l’esercito comune sia pronto ad assediarti»
Il tono cupo in cui Ahmed pronunciò il discorso iniziò a preoccupare Ivan: era davvero possibile una cosa del genere? Dopo secoli di dispute, territori contesi e conflitti interni e tra loro, i falsi leviatani erano davvero diventati così baldanzosi da sperare di potersela vedere con lui, la loro più grande paura condivisa? Se era vero, Ivan non poteva accettarlo: la sua stirpe era stata una costante universale per secoli. Da generazioni, Molnii era il più grande terrore della società: era il promemoria vivente che non importava la potenza di un impero, i veri padroni del mondo erano i titani; e chi ne stringeva il potere. Come osavano ignorare quella sacrosanta verità? Il loro attaccamento ai loro beni materiali aveva dunque superato il loro timore di lui? Non avevano più paura di avere le vite di interi popoli sulla coscienza? Ivan sentì la rabbia divampare nel suo petto, ma si sforzò di trattenerla ancora un po’: prima doveva averne la conferma definitiva.
«Esigo delle prove, perché stento a credere che le monarchie siano tanto audaci. Non so che motivo avresti per mentirmi, ma se scopro che ti stai prendendo gioco di me, non sarò così clemente da ucciderti»
Ahmed annuì con riverenza:
«Sono ben consapevole di quanto sembri improbabile un tale fenomeno, ma per fortuna ho con me un’evidenza difficile da confutare. Ti spiace seguirmi fuori dal borgo?»
«Volentieri: devo ancora sgranchirmi le gambe dopo aver volato per giorni»
E così, Ahmed iniziò ad accompagnare Ivan lungo le vie di Svobodaburgo, mentre il signore dei reietti faceva sciogliere le articolazioni delle gambe a ogni passo. Al loro passaggio, gli abitanti si inchinavano con rispetto e timore, com’era giusto che fosse. La soddisfazione di vedere il suo ruolo riconosciuto e apprezzato non svaniva mai. Quando giunsero sulla sponda dell’isola, Ahmed indicò il rottame di una stranissima barca come Ivan non ne aveva mai viste. Non ne era sicuro fino in fondo, ma sospettava che provenisse dalla stessa civiltà perduta a cui Luigi Franchi si era ispirato per forgiare la sua armatura unica nel suo genere, assieme alla spada.
«Affascinante. Che roba è? Perché è conciata così?» domandò.
Ahmed guardò il relitto con uno sguardo afflitto e sospirò:
«Un aeroscafo aleutiano, soltanto una delle innumerevoli meraviglie tecnologiche che io e i miei soci abbiamo riesumato studiando gli abitanti della Terra Cava. Ma purtroppo, i Sapientes non sono più gli amanti della conoscenza di una volta: ormai anche loro si sono lasciati sedurre dalle ambizioni della politica e ora ci marciano dentro!»
«Ah, sì?»
«Ebbene sì: vedi, uno dei più grandi misteri su cui indaghiamo dalla nostra fondazione in epoca romana è la natura dei Ghidorah, “coloro che sono molti”. La prospettiva di abbattere il tuo esemplare li tenta, poiché consentirebbe loro di studiarlo da vicino. Ecco perché, con mio estremo rammarico, hanno sostenuto il progetto dell’esercito comune, infrangendo così la nostra tradizione di apoliticità»
«Osano anche solo sognare di poter macellare la carcassa di Molnii come un bue morto per vedere com’è fatto? Questo è un insulto!»
«Lo credo anch’io. Ma non è ancora tutto: non ti ho spiegato cos’ha ridotto il mio aeroscafo in questo stato. I Padroni di Titani, al contrario dei re e degli imperatori, sanno bene quanto sei potente. Erano molto scettici, quando il progetto è stato avallato, ma è stato allora che i Sapientes li hanno persuasi presentando il loro campione. La sua mera presenza è bastata per instillare ardore nei loro animi: ora lo seguiranno in prima fila, uniti contro il tuo Ghidorah. Quando ho espresso il mio disappunto, i miei stessi soci si sono rivoltati contro di me e hanno deciso che ero di troppo. Sono sfuggito all’esecuzione per miracolo, ma non prima che il loro campione danneggiasse il mio velivolo nella fuga»
Ivan osservò meglio i danni dell’aeroscafo e impietrì: riconosceva quei segni. Era impossibile confonderli. Li aveva visti numerose volte tra le macerie, sulle carcasse di titani morti, sul paesaggio sfregiato da quell’energia devastante. C’era solo una persona che poteva esserne responsabile, fuori dalla natura selvaggia. La sua ira cominciò a diventare incontenibile: Ivan si sentiva sempre più caldo, sudava, gli pulsavano le orecchie e sentiva il sangue confluirgli alla testa. Strinse i pugni così forte che le unghie gli incisero i palmi delle mani. Si avvicinò all’aeroscafo e passò la mano sui segni; dopodiché, si voltò verso Ahmed e mormorò:
«È stato chi penso io?»
«Ti riferisci all’Ammazzatitani? Proprio così: sarà lui a condurre i titani dell’esercito dei regni. Ha promesso ai padroni di titani di spiegare loro ogni tuo segreto, per aiutarli a sconfiggerti»
Era la goccia che faceva traboccare il vaso. Ivan iniziò ad ansimare a denti stretti, per poi urlare a pieni polmoni come una bestia rabbiosa. Tirò un possente calcio a un sasso e lo gettò al largo del fiume Enisej con un grosso schizzo d’acqua. Con un altro urlo, tirò un pugno all’aeroscafo così forte da lasciarci una lieve ammaccatura. Ahmed fece dei passi indietro, intimidito, e Ivan sbraitò:
«Che cazzo hai detto?! Che c’entra Alford in tutto questo?! Come si permette?! Figlio di puttana! Traditore! Egoista! Ipocrita di merda!»
Quel barbaro ingrato non conosceva proprio vergogna: dopo tutto il lavoro che avevano svolto insieme, ora istigava tutti i padroni di titani contro di lui? Non solo gli si era rivoltato contro, non solo gli aveva voltato le spalle nonostante Ivan gli avesse dato uno scopo nella vita, ma a distanza di anni aveva la faccia tosta di dichiarargli guerra. Cos’era quella storia? Avevano tutti dimenticato a chi stavano pestando i piedi?
“È proprio il caso che rinfreschi la memoria a quei miserabili boriosi” si disse, malizioso.
Al centro del borgo, Molnii si era accorto da lontano della sua sfuriata e ora le tre teste lo stavano fissando con sguardi interrogativi. Ivan rivolse un sorriso al suo titano: ora che ci pensava, non gli sarebbe dispiaciuta affatto una bella rivincita. L’unico motivo per cui non era mai andato a cercare Alford dopo che avevano preso strade diverse era che, secondo lui, vivere in solitudine col peso del giudizio del mondo intero era già una punizione sufficiente. Ma se Alford era disposto ad arrivare a tanto pur di essere benvoluto dagli altri, gli avrebbe ricordato volentieri chi comandava. Ahmed si schiarì la voce:
«Ne deduco che il vostro screzio sia una ferita ancora aperta. Comunque, ora che sono riuscito ad avvertirti degli ultimi sviluppi politici, mi sono tolto un gran peso»
Ivan lo guardò negli occhi, gli si avvicinò e chinò la testa:
«Ti ringrazio, Ahmed Ibn-Sina. Se vuoi unirti a noi, le porte di Svobodaburgo ti saranno sempre aperte»
«Apprezzo l’offerta, ma non mi tratterrò a lungo: giusto il tempo di riparare il mio aeroscafo, dopodiché ho intenzione di oppormi alla corruzione dei Sapientes. Forse alcuni di loro sono ancora in tempo per rinsavire»
«In questo caso, sei libero di usare tutte le risorse e gli strumenti nel nostro deposito. Però ti sconsiglio di andare nelle capitali dei regni, nei prossimi giorni»
Ahmed alzò un sopracciglio e Ivan sogghignò:
«Dopo le celebrazioni di domani, io e Molnii partiremo per un giro dell’occidente. Vedremo di fargli abbassare la cresta»

Franko (Guest) on Chapter 1 Sun 14 Aug 2022 12:55AM UTC
Comment Actions
Roberto_Turati on Chapter 1 Sun 14 Aug 2022 03:23PM UTC
Comment Actions